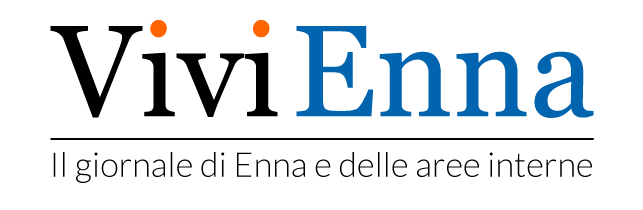Enna. Le tavolate di San Giuseppe
Enna-city - 28/08/2013
 Come Carnevale e Pasqua, la festa di S. Giuseppe, che coincide con l’equinozio di primavera, affonda le sue radici in uno stesso complesso rituale che accompagnava, in civiltà agrarie primitive e poi greco-romane, il ciclo annuale di morte e rinascita della natura. Il tempo, concepito prima dell’avvento di Cristo in forma circolare come un eterno, ma rischioso, ricominciare dal principio, era scandito dai ritmi della terra e il calendario dei lavori segnava anche la vita della comunità. Nel momento più difficile dell’anno agricolo, l’inverno, in cui si sentiva in pericolo la stessa sopravvivenza, il gruppo riaffermava la certezza di un nuovo inizio attraverso una regressione mitica nel caos originario e riti di morte e rigenerazione. L’abbondanza alimentare, l’offerta di cibo, il pasto sacro, ne era fulcro e costituisce ancora oggi parte essenziale delle festività primaverili che da Carnevale giungono fino a Pasqua: propiziazione ed esorcismo contro la carestia, la fame, la morte.
Come Carnevale e Pasqua, la festa di S. Giuseppe, che coincide con l’equinozio di primavera, affonda le sue radici in uno stesso complesso rituale che accompagnava, in civiltà agrarie primitive e poi greco-romane, il ciclo annuale di morte e rinascita della natura. Il tempo, concepito prima dell’avvento di Cristo in forma circolare come un eterno, ma rischioso, ricominciare dal principio, era scandito dai ritmi della terra e il calendario dei lavori segnava anche la vita della comunità. Nel momento più difficile dell’anno agricolo, l’inverno, in cui si sentiva in pericolo la stessa sopravvivenza, il gruppo riaffermava la certezza di un nuovo inizio attraverso una regressione mitica nel caos originario e riti di morte e rigenerazione. L’abbondanza alimentare, l’offerta di cibo, il pasto sacro, ne era fulcro e costituisce ancora oggi parte essenziale delle festività primaverili che da Carnevale giungono fino a Pasqua: propiziazione ed esorcismo contro la carestia, la fame, la morte.
Centrale la festa di S. Giuseppe che, radicata in tutta la Sicilia fin dal ‘600, si celebra ancora, sia pure con minore incidenza che in passato, in molti centri della provincia di Enna – specialmente Nicosia, Aidone, Valguarnera, ma soprattutto Leonforte – con la realizzazione di grandiose tavolate colme di cibi offerti ai poveri che rappresentano i “Santi”: esorcismo rituale anche qui contro il pericolo della miseria, l’insicurezza e l’instabilità sociale. La devozione cristiana a S. Giuseppe e alla Sacra Famiglia, attualizzata talora da vere e proprie rappresentazioni sacre (la “Fuga in Egitto” ad Assoro, la “Sagra dei soldati di Erode” a Pietraperzia), si innesta in maniera naturale sull’arcaico substrato.
La tavolata porta a compimento un voto personale per grazia ricevuta, ma la sua realizzazione è frutto di una collaborazione sociale ampia e la sua fruizione riguarda l’intero paese, confermandone l’identità e rinsaldandone i legami. Un tempo si svolgeva una questua preliminare di casa in casa e per le campagne, secondo un’usanza, ormai quasi del tutto abbandonata, comune ad altre feste religiose e persino all’antico Carnevale descritto da Guastella e da Pitrè. Attraverso l’affermazione del diritto-dovere di chiedere e di dare, essa affermava, nella generale povertà delle comunità contadine dell’entroterra siciliano, il diritto di tutti alla sopravvivenza, ed era perciò strumento riconosciuto, valido a ravvivare vincoli essenziali di solidarietà.
Nella mensa si ritrova la forma più antica ed elementare di altare: dalle grandi mense sacre delle antiche culture del mediterraneo orientale all’agape cristiana, il pasto comunitario dei primi cristiani per ricordare l’Ultima Cena. A Enna città la tavolata, oggi rarissima, veniva addobbata coi paramenti sacri delle chiese. A Leonforte essa si chiama proprio “artaru”. Di grandezza variabile, a seconda del numero di Santi cui è dedicata, addossata a una parete su cui campeggia l’immagine di S. Giuseppe o della Sacra Famiglia, è costruita (un tempo con “trispiti” e tavole del letto) a ripiani su cui, secondo un ordine preciso, trovano posto i cibi prescritti. Le verdure spontanee – cardi spinosi, finocchietto selvatico, asparagi – che costituiscono il residuo più arcaico di una economia primitiva di raccolta, e le frittate vegetali; i legumi, specialmente ceci e fave, tipici dell’ennese; le primizie di ogni genere, che nei riti classici di inizio d’anno venivano offerte ai defunti; frutta e specialmente arance, in ragione di una per ogni Santo; vino, e dolci tra cui le tipiche sfinci, mostarda e pignolata. Pasta con la mollica “atturrata” e soprattutto pane. Un tempo fatto in casa dalle donne e lievitato naturalmente col “criscenti”, ma sempre spennellato di chiara d’uovo e cosparso di “paparina”, esso è il vero protagonista delle tavolate, tanto che a volte (Leonforte, Villarosa) si fanno altari di solo pane. Varie, ma immutate nel tempo, le sue forme: la “cuddura” innanzitutto, già conosciuta e chiamata allo stesso modo dai greci, simbolo, come il serpente che si morde la coda, del cerchio del tempo che si rinnova – una per ogni santo, la più grande e la più bella per Gesù; la “palma” per la Madonna; “a manu”, “a varva”, “u vastuni” di San Giuseppe con la fioritura del giglio; il pesce, simbolo paleocristiano di Gesù; “a spera” dell’ostensorio; “u marteddu”, “a scala”, “a tinaglia” che alludono all’imminente Crocefissione; “pupidduzza” e “panuzzi” che evocano forme animali e vegetali, simbolo della rigenerazione della natura.
Dietro a tutto questo l’attività solidale delle donne, che in gruppi familiari e amicali si curano della realizzazione dell’altare. Dall’inizio – con la preparazione dei cibi, cuocendo tra l’altro ancora oggi, nei tre giorni precedenti la festa, le verdure selvatiche in enormi “quadaruna” sul fuoco davanti alla porta di casa – fino alla fine, con l’accoglienza delle allegre comitive di visitatori durante l’intera notte della vigilia (tutti devono asssaggiare e non si dice grazie), e il “servizio” del pranzo di mezzogiorno ai Santi. La tavolata appartiene alla donna, è lei “a patruna di l’artari”. A lei rimane il pane più significativo, “u vastuni” di S. Giuseppe. Ministro naturale di un rito arcaico di rinascita, in quanto forza cosmogonica, capace di produrre e riprodurre la vita, depositaria di fecondità, fertilità e abbondanza. Al prezioso corredo nuziale delle donne appartengono le tovaglie bianche della mensa; coi loro veli da sposa, messi abilmente insieme da mani femminili, si fa a Leonforte “u celu”, la parte più scenografica che corona l’altare, come un aereo catino d’abside o un’arabeggiante, vaporosa volta a nido d’ape. Alle donne spetta la preparazione dei piatti col “lavùri”, il grano germogliato al buio e collocato ai due angoli in fondo alla tavolata che, come nel rito greco-siculo dei “giardini di Adone”, allude alla vicenda del Dio che muore e rinasce come la vegetazione.
Nella rispondenza reciproca tra le grandi feste del ciclo primaverile, Eros e Tanatos, dunque, vita e morte si riversano eternamente l’una nell’altra. “U lavùri” si ritrova nelle cerimonie del giovedì santo, assieme al pane, il vino e le arance, e alla lavanda dei piedi che si usava ai Santi, prima del pranzo rituale. All’Ultima Cena appartiene il numero massimo di santi per un altare: tredici (a Villarosa sono tredici “virgineddi”). Almeno tre altari, come tre sepolcri il giovedì santo, “si firrìano” a S. Giuseppe.
Cinzia Farina