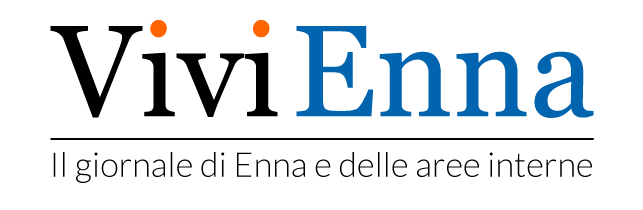Libera Università della Politica 3° Memorial Padre Ennio Pintacuda S.J.
Enna-Cronaca - 27/08/2009
La Libera Università della Politica torna a Filaga per offrire una piattaforma permanente di formazione e dibattito per il potenziamento della comunità politica e come nodo autorevole dell’armatura culturale e civile del territorio.
Il crollo delle illusioni di una crescita economica esponenziale e senza controlli e l’attuale crisi come grande catarsi di una società fondata sull’idolatria della demagogia e dell’egoismo ci rivela la luminosità di una via allo sviluppo fondata sull’etica, sulla responsabilità e sulla cooperazione. Crollata la grande illusione, sepolti i miti del consumismo sotto il terremoto del global change finanziario, possiamo riscoprire il valore di abitare una società della conoscenza e perseguire nuovi obiettivi mutati con grande celerità.
Nel riannodare i fili intessuti nelle precedenti edizioni del Laboratorio di Filaga abbiamo il compito e la responsabilità di re-immaginare il ruolo della Libera Università della Politica e le sue relazioni con tutte le realtà dell’alta formazione del pensiero e con il territorio. Una nuova Filaga interattiva e cooperativa è quella che vogliamo proporre per il 2009. Una “Filaga 2.0” che costituisce un’occasione per attivare un indispensabile political network che alimenti, rafforzi ed attivi la comunità politica, capace di giocare le sfide che ci si presentano di fronte.
Nel nuovo scenario caratterizzato dalla qualità e dall’innovazione, la missione della Libera Università della Politica è quella di essere un motore culturale capace di alimentare costantemente la domanda di formazione, di dibattito e di crescita culturale della comunità in cui agiamo.
La presenza del Laboratorio Filaga, radicato nella sapienza antica del territorio dei Sicani e connesso da mille fili al vasto territorio dei saperi locali, intende favorire l’avvio di filiere di formazione, elaborazione e sviluppo funzionali alle vocazioni, alle risorse e alle opportunità del territorio, promuovendo in maniera permanente l’integrazione della formazione politica con il sistema culturale, politico, sociale e produttivo.
Scrive Peggy Noonan, una delle più acute editorialiste del Wall Street Journal, che dal 1968 al 2008 i baby boomer sono stati l’esercito di formiche che ha generato e goduto la Grande Abbondanza. Ma si accorgono ora che quell’era che loro costruirono si è chiusa, qualcosa di nuovo sta emergendo dalle macerie del terremoto finanziario globale. “Le vecchie manifestazioni esteriori del successo – denaro, status, potere – non avranno più esattamente lo stesso appeal di prima”. Dagli anni Settanta abbiamo vissuto un periodo aureo in cui il meccanismo degli aumenti di reddito e l’incremento costante, talvolta patologico, dei consumi hanno alimentato un ciclo di espansione senza precedenti, in un contesto di crescenti liberalizzazioni di commercio e finanza che si è nutrito dell’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’inevitabile punto di frattura del meccanismo era reso invisibile dal bagliore dei profitti: un eccesso d’indebitamento delle famiglie per finanziare la turbina dei consumi, un eccesso di squilibrio delle bilance correnti degli Stati per reggere il divario tra risparmio e investimenti, una divaricazione parossistica tra valore e lavoro, tra la finanza e l’economia reale – tra Wall Street e Main Street come si dice con un’efficace metafora. Il meccanismo ha mostrato la sua prima crepa nel 2000 con lo scoppio della “bolla internet” ed è crollato definitivamente nel 2008 con l’esplosione della “bolla immobiliare”.
Le conseguenze, come sappiamo, sono una drammatica caduta dei consumi con conseguenze sulla produzione e sull’occupazione. Ma all’interno di questa contrazione emergono segnali importanti di modificazione della composizione stessa dei consumi, spostandosi verso una maggiore attenzione alle caratteristiche d’uso dei prodotti e dei servizi, al processo produttivo che li ha generati, alle prospettive di smaltimento, al consumo energetico e all’impatto ambientale. Numerose sono le esperienze di transition community avviate nel 2009 negli Usa per guidare un modello di sviluppo verso stili di vita a basso consumo di suolo, di energia, di mobilità. Un modello di nuova comunità in cui il cambiamento di stile di vita sia condiviso, cambiando abitudini in maniera cooperativa, senza tensioni tra visioni ma lavorando insieme per ridefinire le regole del gioco.
Il capitalismo contemporaneo – definito turbo-capitalismo, iperliberismo o mercatismo – ha mostrato il suo volto egoista. I tratti distintivi di questa patologia – analizzata da Oliver James nel suo libro Il capitalista egoista – sono quattro: “Il primo è che il successo di un’azienda è giudicato dalla sua quotazione in Borsa, invece che dalla sua forza intrinseca o dal contributo che può offrire alla società e all’economia. Il secondo è una forte spinta a privatizzare i beni e i servizi della collettività. Il terzo è una regolamentazione minima dei servizi finanziari e del mercato del lavoro, tesa a favorire i datori di lavoro rendendo più semplici i licenziamenti. Infine l’imposizione delle tasse non punta a ridistribuire la ricchezza: per le grandi aziende e per i ricchi è più facile evitarle e rifugiarsi nei paradisi fiscali senza infrangere la legge”.
L’attuale crisi – ci spiega Jacques Attali – mostra che se il mercato è il migliore meccanismo di ripartizione delle risorse rare, è però incapace di creare lo Stato di diritto di cui ha bisogno e la domanda necessaria al totale impiego dei mezzi di produzione. Affinché una società di mercato funzioni efficacemente, occorre allo stesso tempo uno Stato di diritto che garantisca il diritto alla proprietà, imponga il mantenimento della concorrenza, crei una domanda attraverso salari accettabili e commesse pubbliche. Ciò presuppone un intervento politico, democratico, nella ripartizione dei redditi e dei patrimoni. Non è la crisi del capitalismo quella a cui assistiamo, ma la crisi del ruolo vicario del mercato rispetto alla politica, il crollo del mito della capacità generativa degli “spiriti animali” del mercato. Invece è la politica – come responsabilità del benessere collettivo – ad avere maggiore capacità generativa del valore, poiché agisce su un numero maggiore di componenti dello sviluppo che non possono essere sussidiate dalla finanza, come dimostrato in questi mesi.
Quando saremo usciti dalla crisi globale, quando avremo rafforzato il ruolo della politica e ricostruito il tessuto economico devastato dall’ebbrezza dei derivati, quando avremo riconnesso la relazione valore-lavoro, allora un’eredità durevole della ricostruzione post-crisi sarà la scomparsa di un certo spirito, la caduta di un modo di vedere la vita che è irrimediabilmente superato. Dopo il crollo dei “falsi idoli” costituiti dalle demagogie e dagli egoismi, l’uomo potrà riprendere la capacità di esercitare una rigorosa etica della responsabilità, in cui la partecipazione allo sviluppo sarà reale e le libertà individuali agiranno entro l’interesse collettivo.
Lo scenario di un nuovo capitalismo, di un nuovo ambiente e di una nuova società ci induce a rivedere l’agenda politica, inserendovi opzioni che riguardano la conservazioni delle risorse irriproducibili, la governance degli insediamenti, la sostenibilità ecologica delle decisioni, la gestione delle risorse energetiche e la ricostruzione del rapporto valore-lavoro. L’etica della responsabilità a cui siamo chiamati ci impone che, una volta assicurata la sostenibilità ecologica degli insediamenti, dovranno essere attivate azioni concrete per il recupero creativo delle risorse aggredite o degradate dalle varie attività umane, attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità locali intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il territorio, con l’ambiente e il paesaggio.
Esiste un ulteriore scenario di uscita dalla crisi che ci coinvolge in prima persona. Riguarda la consapevolezza che nel corso della storia, fin dalla nascita del capitalismo nel XII secolo, ogni crisi s’innesca nel “cuore” economico e politico del mondo e al superamento della crisi corrisponde la nascita di un altro cuore che sposta i baricentri e ridisegna le relazioni. Anche oggi il sisma inizia negli Usa e in Gran Bretagna e si diffonde con la forza brutale della globalizzazione in tutto il pianeta, coinvolgendo orienti e occidenti, nord e sud. La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore malato del turbo capitalismo anglo-americano il capitalismo responsabile e reticolare del Mediterraneo, approfittando dell’occasione per consolidare e accelerare la costituzione dell’Unione del Mediterraneo lanciata lo scorso anno da Sarkozy come grande progetto politico, economico, culturale e sociale. Anche la nascita di un nuovo centro con quasi 500 milioni di abitanti (di cui quasi due terzi nella sponda sud-est), con radici profonde nella storia e con lo sguardo proteso verso il futuro, non più guidato solo dall’idolatria del mercato e dalla produzione di valore immateriale è la sfida che ci attende dopo la crisi.
Le giornate di Filaga non intendono solo discutere di come rianimare il cuore malato dell’Occidente, ma come agevolare la nascita di un nuovo cuore finanziario, produttivo e culturale, e quindi politico. Nella competizione tra Usa e Cina – falsa perché le due nazioni sono legate da relazioni inestricabili – l’Europa rischia di essere considerata di nuovo un soggetto ancillare, un portatore d’acqua al mulino della macchina industriale cinese e della voragine consumistica statunitense. Numerosi analisti ormai definiscono il nuovo ordine mondiale derivante dalla crisi come la trasformazione del G8 o del G20 in un G2 tra Cina e America, la cosiddetta Chimerica: un soggetto duale per il governo mondiale. La nascita di un nuovo soggetto Euro-Mediterraneo, invece, porterebbe nuove economie e risorse, ma anche talenti e volontà, accelerando realmente i necessari processi di pace e contrastando una radicalizzazione a due teste della globalizzazione post-crisi.
Il tema della rinascita dopo la crisi e la conseguente necessità di ricostruire la comunità politica su nuove basi e su nuovi centri, sarà articolato in sessioni tematiche, le quali permetteranno di sviluppare il tema della rinascita attraverso la tensione collettiva per una profonda trasformazione dell’impegno politico attraverso i seguenti approfondimenti:
• nelle economie globalizzate la sfida è sui saperi, tra la leadership di giovani generazioni;
• i beni collettivi, una straordinaria occasione di coesione sociale e di sviluppo;
• energia e ambiente, le sfide del terzo millennio per uno sviluppo etico e sostenibile;
• l’economia e la politica oltre la crisi: la ricostruzione della fiducia;
• il Mediterraneo del terzo millennio: dalla immigrazione clandestina alla integrazione economica nel rispetto delle culture e delle religioni;
• il federalismo come occasione per ripensare la rappresentanza politica.
Ogni sessione sarà affrontata attraverso un momento formativo, costituito dalle lezioni della Summer School ed un momento di riflessione e dibattito, costituito dalla tavola rotonda serale.
L’ambizione dell’8° Stage di formazione socio-politica è quella di approfondire i temi che emergono dalla crisi, politica prima che economica, di principi prima che di regole, di responsabilità prima che di decisione. Tale finalità s’intreccia con il proposito della Libera Università della Politica di contribuire a ritessere i fili del dibattito politico e culturale per ricostruire il tessuto di comunità che deve sorreggere e contenere le strategie di sviluppo della Sicilia.
Nelle economie globalizzate la sfida è sui saperi, tra la leadership di giovani generazioni
Dalle economie globali a quelle locali: in un’economia basata sul sapere, le competenze hanno un impatto che si manifesta in diversi modi. Le conseguenze possono incidere su settori come gli investimenti diretti esteri, l’innovazione, la coesione sociale.
Emerge il bisogno di rafforzare il bagaglio di conoscenza dei “knowledge worker” (nuovi eroi, il paradigma di una rivoluzione silenziosa del nuovo millennio, così come l’operaio-massa è stato l’icona della società industriale fino a tutto il Novecento), con particolare attenzione a quelli poco qualificati che hanno necessariamente bisogno di un nuovo e maggiore know-how che non riguarda solamente la dimensione cognitiva e razionale (a cui spesso è “ridotta” la cultura scientifica occidentale ) ma è al tempo stesso pratica, cognizione, emozione, relazione, etica ed inoltre capacità di comprendere, indirizzare, cambiare e mobilitare saperi diversi al fine di generare risultati d’eccellenza (spesso collettivi).
Il bagaglio conoscitivo, allora, che si ritiene essere di maggiore importanza è il “know-how socioculturale”, che deve fornire a chi detiene la leadership gli strumenti necessari a comprendere le dinamiche interne ed esterne all’organizzazione.
Siamo la società della conoscenza, dell’intangibile e l’innovazione, oggi universalmente considerata come uno tra i fattori principali della competitività, richiede processi di creazione, diffusione e ricambio delle conoscenze. L’innovazione non ha confini, l’innovazione riguarda ogni aspetto della realtà delle organizzazioni.
Organizzare il lavoro della conoscenza significa creare continuamente regole, attività, strumenti, competenze, decisioni, attribuzioni di senso su come persone, organizzazione, tecnologie possano far emergere e condividere gli elementi poco noti dei processi conoscitivi, quali le scoperte scientifiche, lo sviluppo di prodotti, il miglioramento dei processi di progettazione e d’organizzazione del lavoro (sviluppo della cultura organizzativa) e i nuovi saperi tra cui il “saper dover essere” (che sviluppa l’etica e la morale nelle persone umane), il “saper benessere” (che si orienta verso lo sviluppo della qualità della vita) e “l’essere per saper essere” (che aiuta le persone a sviluppare l’autostima e l’autoriconoscimento).
Nel nuovo scenario, la formazione dovrà riuscire a creare i fondamenti per la creazione di uno stile di leadership appropriato ad ogni situazione che si viene a creare. Questo si ottiene tenendo conto delle competenze dell’intelligenza emotiva, che sono alla base di una leadership efficace e soprattutto della “leadership ideale”, che si basa sulla scoperta del sé ideale (chi si vorrebbe essere) e del sé reale (chi si è effettivamente). Conoscendo chi si è realmente, si potrà tracciare la strada per raggiungere i propri obiettivi (diventare, cioè, chi si vorrebbe essere). Questo processo fa parte, quindi, di un cammino d’apprendimento che serve al leader per allenarsi a raggiungere i propri sogni.
In tal senso s’inserisce il ruolo della formazione est-etica. Posto che il processo d’apprendimento è un processo psichico e sensoriale che deve decodificare l’esperienza per modificare ed evolvere le proprie esperienze, capacità ed atteggiamenti, la formazione est-etica coniuga la responsabilità dei formatori, che è costituita dal farsi carico dei risultati conseguiti tramite le proprie prestazioni professionali, con lo sviluppo dell’emozionalità nell’apprendimento. Questa, se orientata al livello logico valoriale, è una formazione che mantiene nel tempo il suo effetto migliorativo ed è ritenuta particolarmente efficace nel modificare i comportamenti agiti.
La leadership ed il significato che questa ha assunto negli ultimi tempi, sono sempre più connessi alla società della conoscenza, essendo la leadership fortemente collegata alla mobilitazione d’energie per il cambiamento ed il raggiungimento di risultati.
I giovani, la politica e l’amministrazione. Esperienze
In mezzo a successi, fallimenti, manovre e intrighi, la politica e i politici si dividono da sempre tra la ricerca del bene comune e quella, assai meno edificante, del tornaconto personale. Quale dei due atteggiamenti prevalga alla fine bisognerebbe forse chiederlo ai tanti che, per slancio o convenienza, giorno dopo giorno scelgono il difficile mestiere di gestire la cosa pubblica. Anche la recente tornata elettorale ha dimostrato che, dentro questa folla variopinta di “parvenu”, è sempre più consistente la presenza di giovani: se non nei santuari della politica nazionale, custoditi gelosamente da vecchie volpi e capitani di lungo corso, almeno nelle realtà locali, che sono speso il luogo delle novità più eclatanti, della sperimentazione e perfino dell’azzardo.
Alla politica i giovani chiedono una vetrina per mettersi in luce, una palestra per misurare le proprie capacità o semplicemente l’occasione di trovare un impiego sicuro, dalla politica, invece, spesso ricevono in cambio una lezione memorabile sull’emarginazione e il disinganno. Di fatto, quando non vengono trattati alla stregua di soprammobili, magari belli a vedersi ma privi di reale utilità, vengono relegati nell’ambito angusto e non meglio definito delle “politiche giovanili”. E lì restano a maturare: fanno la gavetta, imparano a rispettare le gerarchie, assimilano i trucchi del mestiere. Come risultato, questi giovani politici hanno le facce “invecchiate” troppo in fretta di chi è costretto a comportarsi da adulto, lo sguardo smarrito di chi non è abituato alle luci della ribalta oppure, nella migliore delle ipotesi, l’espressione sciocca e compiaciuta di chi si accontenta di apparire.
Tutto questo non è da giovani, né da aspiranti politici. Che cosa dovrebbero fare i giovani in politica è insieme straordinariamente semplice e complicato. Fare i giovani, innanzitutto: innovare il mestiere del politico piuttosto che limitarsi a impararlo presto e bene, guardarsi intorno con la curiosità del neofita, agire con slancio e – perché no? – con imprudenza, “dimenticare i padri”: prendere consiglio e poi disobbedire, ribellarsi, cambiare. E soprattutto gridare forte la propria voce. In fin dei conti è questo che la gente comune attende dalla politica: una voce nuova, un accento diverso, non ancora ascoltato.
I beni collettivi: una feconda occasione di coesione sociale e di sviluppo
Il patrimonio culturale delle città e dei territori europei è un palinsesto di vasta e ricca diversità, segno tangibile delle identità locali e contemporaneamente vettore di sviluppo. L’identità culturale, il paesaggio e la qualità dell’ambiente non possono più limitarsi a chiedere misure di protezione, ma richiedono un forte impegno politico, scientifico e tecnico per affrontarli come beni collettivi, come generatori di nuova identità e non solo testimoni della storia. L’Unione Europea, nei suoi documenti più recenti, ci indica l’impegno verso uno sviluppo sostenibile ispirato ad un atteggiamento più creativo, non solo in grado di lasciare in eredità alle generazioni future un patrimonio territoriale intatto, ma addirittura arricchito di nuovi valori per la comunità. La direzione da sperimentare è quella di una “gestione creativa” dei paesaggi culturali e naturali, in grado di favorire la loro coerenza d’insieme e di invertire la tendenza all’abbandono, al degrado e alla distruzione, primo passo verso forme improprie di valorizzazione esclusivamente monetaria. Lo scenario di un nuovo capitalismo, un vero e proprio “Capitalismo 3.0” ci induce a rivedere l’agenda politica, in cui le opzioni che ne derivano consistono innanzitutto in una conservazione a lungo termine ed in una gestione permanente dei paesaggi d’interesse culturale e storico attraverso una forte integrazione con la sostenibilità ecologica, con la pianificazione territoriale, con la gestione dell’uso dei suoli e con la produzione di valore.
Un approccio alla qualità del territorio come bene collettivo ci richiede una governance che sia contemporaneamente responsabile, sostenibile e creativa, proponendosi come un integratore di differenti sostenibilità. Una sostenibilità dell’ecologia urbana che recuperi la visione del “metabolismo” in termini di impatti ambientali ed energetici degli insediamenti. Un’economia urbana sostenibile capace di distribuire lavoro e ricchezza ed una società sostenibile capace di assicurare coesione sociale e solidarietà. Una città in cui abitazioni sostenibili anche dal punto di vista energetico diano un alloggio sicuro per ogni cittadino creando un ambiente urbano che protegga e alimenti gli eco-sistemi urbani. Un territorio caratterizzato da un’accessibilità sostenibile che generi una mobilità capace di conservare risorse e non sprecare energie. Ed infine una democrazia urbana sostenibile che alimenti la responsabilizzazione della cittadinanza. Le regole per il buon governo possono essere sintetizzate in incrementare la sussidiarietà e solidarietà, lavorare con i mercati, individuare nuove forme di partecipazione, facilitare l’azione integrata dei diversi livelli di governo, individuare le priorità, decentrare i servizi e separare la politica dei servizi dalla loro erogazione.
Appare evidente che la maggior parte delle questioni e delle esigenze per uno sviluppo sostenibile fondato sui beni collettivi non possono essere strutturate all’interno dei tradizionali confini disciplinari e settoriali. Inoltre, la sfida del cambiamento climatico, la crisi della globalizzazione e l’aumento della domanda di risorse, chiede un ulteriore sforzo interdisciplinare nel modo di affrontare i rapporti tra ecologia, economia, pianificazione, società e tecnologia. In questo contesto, anche i tradizionali ruoli e le responsabilità dei decisori, degli studiosi e dei professionisti devono essere ridefiniti. Oggi torna all’attenzione l’approccio al “metabolismo urbano” come processo per agevolare la transizione verso una più efficace sostenibilità. Il nuovo approccio al metabolismo urbano non si limita a ripensare lo sviluppo delle città, ma incrocia anche le questioni dello “sviluppo rurale”. Il nuovo modello insediativo, infatti, può essere definito come l’interazione complessa delle risorse tecniche e socio-economiche e dei processi produttivi che si verificano nelle città e nei territori rurali, generandone la crescita e la diversificazione, la produzione di risorse alimentari e la qualità del paesaggio, la produzione di energia e l’eliminazione dei rifiuti. Diversi sono i fattori che influenzano il metabolismo delle città e delle campagne: la forma insediativa, la rete di mobilità, i processi produttivi agricoli e manifatturieri e l’evoluzione delle tecnologie dei trasporti possono influenzare sia il consumo o la produzione di energia che la scelta delle modalità e dei materiali costruttivi. E su tale interazione dovrà agire il buon governo alimentato dall’interazione tra coesione e sviluppo in una nuova alleanza tra città e campagna.
Energia e ambiente: le sfide del terzo millennio per uno sviluppo etico e sostenibile
Energia e ambiente non sono più concetti innovativi, o su cui impegnarsi per diffonderne importanza e valenza strategica per il futuro delle giovani generazioni. Ma certamente la centralità delle tematiche della sostenibilità energetica e della qualità ambientale comporta ancora una forte evoluzione nei modelli adottati quotidianamente da ciascuno degli abitanti della Terra, dai governi e soprattutto dal sistema produttivo
Le imprese hanno uno sguardo privilegiato sul mondo, vivono le grandi trasformazioni economiche sui mercati internazionali e sanno cogliere le sfide imprenditoriali più importanti. Per gli imprenditori, il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale sono dunque prima di tutto sfide imprenditoriali che determineranno la strategia futura dello sviluppo di ogni iniziativa imprenditoriale, e di ogni politica economica. Allo stesso tempo tutti stanno prendendo coscienza di come l’ambiente sia al tempo stesso fattore di competitività, una risorsa aggiuntiva e non solo un problema di costi. I vantaggi di questa impostazione per le aziende sono molteplici. Adottando una strategia impostata sulla protezione dell’ambiente e sul risparmio di energia e materie prime, esse possono trasferire direttamente nel loro conto economico i vantaggi e i risparmi dell’accresciuta competitività.
Una delle sfide del futuro per le imprese a livello internazionale e nazionale sarà dunque quella di saper trasformare le sfide climatiche e la sostenibilità ambientale in occasione di crescita e di recupero di competitività. E’ una sfida già intrapresa da molte imprese italiane: nonostante esse siano gravate da costi dell’energia maggiori rispetto ai principali concorrenti europei ed internazionali, hanno effettuato, negli ultimi anni, importanti investimenti per ridurre le proprie emissioni ed aumentare l’efficienza energetica.
Anche per effetto di questi investimenti, secondo uno Studio Enel-Mc Kinsey su dati della Commissione Europea, le emissioni pro capite dell’Italia sono inferiori rispetto alla media UE dell’11%, ed il consumo energetico per abitante è inferiore del 22% rispetto alla media europea.
Questi valori meno negativi di altri nostri concorrenti non devono tuttavia farci dimenticare i nostri problemi di fondo: il nostro Paese dispone di un sistema energetico estremamente fragile e in parte inadeguato a gestire la sfida della competizione sui mercati internazionali.
Come è noto, infatti, a fronte di previsioni di forte crescita dei consumi elettrici (+40 per cento nei prossimi 15 anni), l’Italia, si trova ad affrontare una situazione di estrema dipendenza e vulnerabilità, rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei. Dipendiamo infatti dall’estero per circa il 90% del nostro fabbisogno di energia primaria, con elevati costi di approvvigionamento di materie prime, a causa soprattutto di una scarsa diversificazione del mix delle fonti di produzione. La produzione di energia elettrica dipende infatti dalle fonti fossili per l’81%, contro il 53% dell’Europa. Il gas naturale, dal quale dipendiamo per il 52%, proviene prevalentemente da due soli paesi: Russia ed Algeria, caratterizzati da un elevato rischio di instabilità dal punto di vista geo-politico.
Energia e ambiente costituiscono la sfida del terzo millennio, sulle stesse si dovrà misurare la capacità delle elités dominanti di governare il sistema globale offrendo le risposte necessarie per impedire che il progresso, inteso come prospettiva di vita migliore per un sempre maggiore numero di esseri umani, non si arresti con ricadute catastrofiche non solo per le aree più sviluppate ma soprattutto per quelle che ancora si attardano nel sottosviluppo sia esso economico che civile.
Oggi, di fronte alla sempre maggiore scarsezza delle fonti energetiche tradizionali e al sempre più significativo degrado dell’ecosistema, urge innanzitutto un ripensamento dello stesso modello di sviluppo che il mondo occidentale ha imposto in questi ultimi due secoli, ponendo fine allo sfruttamento dissennato di risorse non rigenerabili e sostituendo lo sfruttamento alla coltivazione dell’ambiente fino a pervenire, laddove necessario, a quella che è stata definita “decrescita conviviale”.Puntare sulle fonti rinnovabili è dunque il passaggio obbligato per garantire non solo le risorse attualmente necessarie al sistema socio-economico ma, anche, per estendere le opportunità, che finora sono state offerte in modo esclusivo ed egoistico ai cosiddetti “nord del pianeta”, anche a quelle aree che dello sviluppo stesso non solo non hanno beneficiato ma che ne hanno pagato i costi più alti in termini di devastazioni degli eco-sistemi e di arretramento economico e sociale.
Ma puntare sulle fonti rinnovabili, opportunità per un rilancio di una economia che rifuggendo dall’inganno del virtuale punti sulla produzione di beni reali utili ad accrescere la ricchezza, può assumere un significato ambiguo fino al punto da generare una nuova spirale di degrado laddove non si individuino strumenti di governance specifici, in grado di superare le barriere statuali. Le nuove politiche energetiche e ambientali richiamano dunque nuovi strumenti di governo per l’adozione di un ecologismo pragmatico che non sia apocalittico né antisviluppista, sul quale fondare convivenze solide e relazioni stabili, ma una tale progettualità richiama necessariamente quei valori etici che, soprattutto in questi anni, la crescita dissennata figlia di un ingiustificato ipertrofismo della ragione, non ha permesso di tenerne adeguato conto.
L’economia e la politica oltre la crisi: la ricostruzione della fiducia
Il mutamento d’epoca in cui noi oggi viviamo ci impone di ripensare criticamente il ruolo ed i compiti che l’economia e la politica devono assumere in un contesto determinato sia dalla velocità dell’incidenza degli eventi sia dalla espansione, altrettanto rapida, della internazionalizzazione della produzione, delle transazioni finanziarie, dei mercati dei beni e del lavoro e dei servizi tecnologico-informatici di supporto.
Tale impegno di pensiero costituisce un dovere professionale che trascende la conoscenza professionale degli studiosi e degli operatori di settore perché ci vincola a riflettere, assumendo un punto di vista generale, sulle dinamiche di dilatazione e di omologazione che tanto più universalizzano, fulmineamente, i processi economici quanto più restringono lo spazio dei mercati ad una mera semplificazione di villaggio globale, fino a fare implodere questa fittizia comunità a guisa di un effettivo contenitore di macro-contraddizioni.
Non è estranea alle ragioni della crisi, più che la società liquida, la liquidità della politica, luogo di fluttuazione sul quale si riversano le grandi ondate delle domande di massa (domande di sicurezza, di identità, di garanzie di cittadinanza, di benessere diffuso ecc.), su cui si liquefanno le grandi visioni di futuro, oscilla la forza delle decisioni pubbliche, traballa l’impianto del tradizionale stato nazionale e manca, infine, una terra d’approdo sulla quale impiantare in maniera solida efficaci ordinamenti democratici sovranazionali.
Per andare oltre la crisi, per tornare a far risplendere nelle due facce dell’ordine civile – quello economico e quello politico – la responsabilità dei decisori, la giustizia dei governanti, il consenso degli amministrati ed il controllo dei destinatari, va superata la paura, coltivata la speranza, costruita la fiducia. E’ necessario cioè inaugurare, dopo Hobbes, un nuovo processo di civilitas che non può che imperniarsi nei valori di filantropia che tengono stretti i nuclei sociali, e i loro interessi individuali e collettivi, dapprima nella unità organica di quella comunità di famiglie che fu la polis e via via negli ordinamenti istituzionali degli stati fino ad aspirare alla realizzazione della cosmopoli.
Superare la paura nell’economia: ovvero superare la paura di restare invischiati nelle conseguenze del mercatismo, di restare intrappolati nel meccanismo del trasferimento dei rischi, di essere prigionieri di una finanza globale che accresce il debito pubblico e quello dei privati, che eccita artificialmente i valori delle operazioni, che ‘droga’, in una parola, la sana economia.
Non si va oltre la crisi se non si collega l’aspettativa di prosperità economica e la salute pubblica della comunità politica alla operosa tessitura di una trama di fiducia, alla resistente rete di una reciproca credibilità.
La ricostruzione della fiducia si basa, infatti, sulla piattaforma della credibilità, sia della credibilità della responsabilità di ciascuno sia della credibilità della responsabilità del sistema economico e politico. Possedere ed avere credito non sono soltanto certificazioni di garanzia di credibilità ma anche un ottimo viatico per intraprese di successo e per azioni di governo.
Ed ancora: è urgente tornare a slanciare i ponti della fiducia economica e politica sui possenti e svettanti pilastri della giustizia sociale, della solidarietà comunitaria, della sussidiarietà non solo tra le formazioni sociali nazionali ma, soprattutto, tra le organizzazioni internazionali.
Pur tuttavia la fiducia va costruita, in economia e in politica, consolidando la reputazione degli attori e secondo una maniera altamente ragionata. La fiducia, infatti, rifugge dalle superficiali valutazioni e dalle improvvisate relazioni interpersonali.
Ricostruire la fiducia in economia vuol dire, appunto, reputazione e vigilanza, cioè possedere da un lato principi etici che orientano la condotta dell’agire economico, dall’altro un sistema integrato di vigilanza micro e macroprudenziale che, in caso di crisi, assicuri il coordinamento fra le autorità economiche, la loro l’adozione di misure correttive o di emergenza, e sedi di concertazione politica interstatali che ripartiscano nel sistema dei diversi livelli delle relazioni internazionali gli oneri che derivano dalla sovraeccitazione o dai collassi dei mercati globali finanziari, industriali, energetici, delle materie prime e di consumo.
La separazione dell’economia mondiale dalla legittimità dei poteri di indirizzo e di controllo della politica, provocata dall’autoreferenzialità dei processi di internazionalizzazione, induce a ricostruire la fiducia nella politica proprio in quanto si chiede – per parafrasare Rathenau – più democrazia in economia, cioè più incidenza della sovranità popolare nelle opzioni economiche strategiche di sviluppo mondiale.
Quando il processo decisionale internazionale saprà dare una prioritaria rilevanza ai progetti di sviluppo elaborati dal basso a partire dalla convergenza dalle aree territoriali del mondo e riuscirà, per la loro gestione, a contemplare accanto alle Agenzie tecniche anche le forme più espressamente rappresentative di autotutela dei popoli interessati, allora potremo intravedere più rispetto più rispetto per il demos, più fiducia per la polis, più efficacia per l’agire politico.
Il Mediterraneo del terzo millennio: dalla immigrazione clandestina alla integrazione economica nel rispetto delle culture e delle religioni
Il Mediterraneo, “continente liquido” secondo la felice definizione di Fernand Braudel, prima che luogo fisico è, e resta, luogo mentale, un luogo di socialità.
La vocazione allo scambio in quanto via d’acqua, ne ha forgiato una dimensione concettualmente più ampia rispetto al mero significato mercantile maturata attraverso l’incrocio di culture e, conseguentemente, della crescita dei saperi come frutto della virtuosa ossigenazione dei singoli contenuti originari. Non c’è, dunque, nello spazio mediterraneo cultura che possa considerarsi immune da positive contaminazioni tali da potersi orgogliosamente e superbamente proclamare autentica ed originale rispetto alle altre. Eppure, proprio il Mediterraneo, piuttosto che luogo di pace storicamente è stato, e continua ad essere, il luogo della contrapposizione, del conflitto che proprio le stesse culture alimentano od originano.
Mediterraneo come confine, tracciato delle differenze, nell’eterno dualismo fra Oriente ed Occidente, l’avere una parte di esso assunto come carattere identitario la trasformazione e l’altra, invece, l’immedesimazione, l’avere assolutizzato gli stessi caratteri senza tenere conto delle naturali mediazioni e conseguenti dissolvenze, piuttosto che sintesi ha generato drammatiche antitesi che, solo apparentemente e per brevi e fortunati (?) periodi sono stati sopiti.
Infatti, salvo che per alcune aree di crisi, tuttavia marginali, la conclusione del conflitto mondiale sembrava aver sancito il trionfo della materialità sulle istanze dello spirito e della rivoluzione dei saperi in cui il progresso tecnico, spesso autoreferenziale, era divenuto obiettivo e traguardo dei modelli di vita dell’intero bacino. In molte parti è invece sembrata manifestarsi un’epoca nuova nella quale “la spada si mutava in aratro”.
La caduta del muro di Berlino, ha tuttavia chiarito che il conflitto covava sotto le ceneri, che la pax occidentale era solo apparente. La riconfigurazione dei rapporti secondo schemi culturali ha infatti fatto riemergere, soprattutto nel Mediterraneo in quanto luogo privilegiato della storia, la radicalità delle culture, la pretesa purezza di portati identitari da difendere e chiudere nell’immobilismo di recinti asettici. Le tentazioni multiculturali o, come sostiene Bobbio, l’autoinvestitura della propria come “unica forma possibile di civiltà”, incubano i germi del conflitto.
Conflitti individuali e collettivi, messa in discussione di quanto sembrava indiscutibilmente acquisito, sono i segni evidenti della necessità di un ripensamento per la costruzione di nuovi orizzonti di senso.
Ecco, allora, che diviene insufficiente e, forse, controproducente la via di uno sviluppo fondato sui partenariati mediterranei così come tracciati a Barcellona.
Lo sviluppo, come crescita equilibrata e compatibile nel rispetto delle vocazioni territoriali, non può fare a meno di ragionare sulle culture, sulla promozione di spazi di dialogo alla cui base sta la rinuncia all’idea di modernità fondata, sono le parole di Raymond Aron, sulla ”ambizione prometeica di divenire padroni ed entrare in possesso della natura grazie alla scienza ed alla tecnica”.
Il Mediterraneo ha, dunque, bisogno di un nuovo e più corretto approccio che, al di là del globalismo livellatore, tenga conto delle differenze come risorse, che adotti nuovi statuti di mobilità, scelta necessaria di fronte al livello esodiale dei grandi processi migratori, che soprattutto favorisca l’incontro delle culture attraverso la comprensione, lo scambio per realizzare integrazione e soprattutto modelli di interculturalità, le cui suggestioni non debbono generare quello che Marc Augé, correttamente, definisce “razzismo alla rovescia”.
Il federalismo come occasione per ripensare la rappresentanza politica
Negli ultimi decenni la spinta al decentramento dei poteri di spesa e di tassazione non ha toccato solo il nostro paese, ma ha coinvolto numerosi altri paesi sia unitari e federali appartenenti alle aree più ricche del pianeta sia i paesi in via di sviluppo. In alcuni Stati, talvolta, la richiesta di più decentramento è diventata una domanda di separazione o secessione e questa istanza dentro i confini nazionali è stata portata avanti da alcuni gruppi politici o da alcune regioni più ricche. Contemporaneamente però, in questi decenni, accanto al fenomeno del decentramento abbiamo assistito al rafforzarsi del fenomeno della globalizzazione e della internazionalizzazione dei mercati e, sempre sulla scena internazionale, abbiamo visto che si sono rafforzate alcune istituzioni sovra-nazionali (ad esempio l’Unione Europea e il WTO). In sintesi in questi decenni ci sono stati più globalizzazione e più decentramento. Come spiegare questi due fenomeni apparentemente in contraddizione tra di loro? Alcuni studi economici hanno evidenziato dei nessi di causalità fra questi due processi spiegando che la crescente globalizzazione ha reso necessario il rafforzamento delle istituzioni sovra-nazionali, ma al contempo, la maggiore concorrenza sulla scena internazionale ha anche spinto gli Stati nazionali a decentrare di più alla ricerca di maggiore efficienza nell’organizzazione nell’amministrazione pubblica. Progressivamente i confini nazionali hanno assunto minore importanza per i cittadini e per le imprese sia perché alcuni beni pubblici tradizionalmente affidati al compito dello stato nazionale vengono ora svolti da entità sovra-nazionali sia perché il mercato internazionale (e non più quello nazionale) diventa l’ambito privilegiato di azione. In altri termini in questi decenni è successo che si è affievolito il senso di unità della comunità nazionale ed in alcuni Stati i cittadini delle aree più ricche sono meno disposti ad accettare i meccanismi di redistribuzione delle risorse verso i cittadini delle aree più povere. Segue che, man mano che il fenomeno della globalizzazione si fa sempre più forte, la questione distributiva delle risorse tra i cittadini di uno stesso paese diventa ancora più importante per la tenuta dell’unità nazionale. Nel caso dell’Europa, ad esempio, alcuni studi hanno riscontrato che queste tendenze centrifughe all’interno dei confini degli Stati nazionali sono aumentate via via che si sono rafforzati i poteri dell’Unione europea.
Per comprendere e governare meglio questi processi occorre innanzitutto chiedersi se il federalismo o decentramento può essere d’aiuto. Le analisi dimostrano che il federalismo rafforza la democrazia, ma affinché questo avvenga occorre un governo centrale forte che regoli bene i flussi redistributivi tra i governi locali e una società civile forte che sia in grado di valutare e controllare. Un altro vantaggio del federalismo è legato alla maggiore sperimentazione e cioè il decentramento crea un ambiente adatto per la sperimentazione di nuove politiche pubbliche a livello locale. Questa sperimentazione se conduce a risultati più efficienti potrà essere adottata anche da altri governi locali. Infine sviluppi molto recenti della teoria economica tendono a dimostrare che il decentramento può portare anche a più crescita economica. Ci sono anche svantaggi (o costi o inefficienze) associati al decentramento ed hanno a che fare principalmente con la presenza di economie di scala e di esternalità nella produzione di alcuni beni pubblici. In questi casi quindi si potrebbe avere una offerta sub-ottimale del bene pubblico locale. Il decentramento potrebbe anche comportare dei costi sia per la duplicazione di alcune strutture amministrative sia perché occorre rafforzare il meccanismo di coordinamento tra i livelli di governo. I fautori di un articolazione dei poteri di spesa e di tassazione più accentrata sono più preoccupati invece di mantenere condizioni di uguaglianza nell’offerta dei servizi pubblici e quindi danno un peso maggiore alla realizzazione di obiettivi di equità e cioè le politiche redistributive.