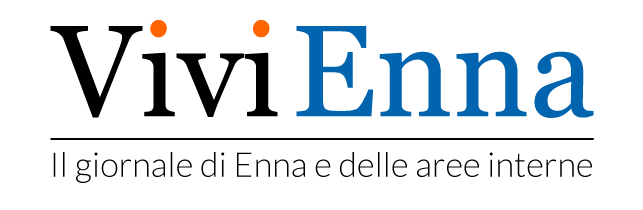Bankitalia: debito impedirà creare lavoro in sicilia per 10 anni
Enna-Cronaca - 17/11/2012
Il debito pubblico creato per fare assunzioni clientelari o assistenziali negli ultimi 40 anni al Sud e in Sicilia ha sì dato momentanea felicità alle famiglie beneficiate da quei “posti”, ma ha ipotecato il futuro dei loro figli e nipoti, che non potranno conquistare un lavoro per almeno i prossimi dieci anni. E’ la conclusione dello studio sullo “Sviluppo diverso delle regioni italiane dal 1861 al 2011” di Giovanni Iuzzolino, capo del Nucleo di ricerca economica della sede di Napoli della Banca d’Italia, presentato oggi a Palazzo Reale in occasione del convegno “Il 1812 e la modernizzazione del sistema economico e sociale”, organizzato dall’Assemblea regionale siciliana in occasione delle celebrazioni del Bicentenario della Costituzione siciliana del 1812.
Per quanto riguarda la Sicilia, secondo Iuzzolino – che aggiunge corruzione e criminalità ai fattori che frenano lo sviluppo dell’Isola e scoraggiano gli investimenti esteri -, bisogna ripartire dalla capacità industriale che è ancora importante, dalla tenuta del sistema bancario e dalla ricchezza ancora presente: “Servono – ha detto – una politica di rigore per una corretta spesa pubblica corrente che ridia fiducia agli investitori, assieme ad un intervento pubblico che sia mirato a pochi selezionati settori che hanno una forte potenzialità economica”.
Due gli esempi: “Basta fare sapere al mondo – ha osservato Iuzzolino – che in Sicilia è possibile realizzare un’industria elettronica di successo, competitiva e duratura nel tempo. Inoltre bisogna recuperare quote di turismo straniero: la spesa dei turisti stranieri in un anno nella regione è la metà di quella della sola città di Milano. Conquistare una quota simile avrebbe un valore di 3,5 miliardi di euro l’anno”.
Guido Pescosolido, ordinario di Storia moderna all’Università “La Sapienza” di Roma, è convinto che oggi sulle prospettive di ridurre il divario Sicilia-Nord pesino “l’incapacità dello Stato di dirottare risorse e la responsabilità della Regione siciliana di non avere sfruttato le possibilità offerte dall’Autonomia né i preziosissimi fondi europei che invece le regioni spagnole utilizzano al 100%”.
Ninni Giuffrida, associato di Storia moderna all’Università di Palermo, ha evidenziato come il processo di riscatto socio-economico della Sicilia, sia cominciato nel 1812: “Quell’anno – ha chiarito Giuffrida – fu il punto di arrivo di una profonda trasformazione della realtà siciliana. Il 1812 fu anche il frutto della necessità che la dinastia borbonica aveva di trovare le risorse finanziarie necessarie per finanziare la guerra contro la Francia. Dare alla Sicilia una Costituzione rappresentava la creazione di un modello da contrapporre all’assolutismo napoleonico”. “Le trasformazioni – ha concluso Giuffrida – consistettero nella crescita di una nuova classe ‘borghese’, nella modernizzazione del sistema amministrativo, nella formazione di una nuova classe politica che mal sopportava l’assolutismo e che puntò sulla necessità di avere una rappresentanza costituzionale”.
Dati e sintesi dello studio di Giovanni Iuzzolino
La Sicilia nel quarto di secolo 1951-1975 conobbe un “periodo d’oro”, grazie all’intervento pubblico che sosteneva con incentivi fiscali e finanziari e disponibilità di manodopera gli investimenti industriali di gruppi nazionali stranieri, che qui erano presenti in maniera maggiore che altrove. Ma non durò abbastanza per consentire la nascita attorno alle grandi fabbriche di un solido tessuto produttivo locale.
Infatti, dopo la crisi del ’75 l’intervento pubblico per l’industrializzazione si trasformò in occupazione tramite forme pubbliche di assunzione (soprattutto uffici, banche e aziende statali o partecipate). Un sistema che non solo non ha creato effetti endogeni e moltiplicativi sull’economia dei territori, ma che ha anche portato il debito pubblico ai limiti massimi sopportabili. La conseguenza è che per ogni soggetto assunto in questi 40 anni non sarà possibile assumerne i figli e i nipoti per almeno i prossimi dieci anni, il tempo ragionevolmente necessario a recuperare un giusto equilibrio fra contenimento del debito pubblico e crescita economica.
Il decennio 1861-1871 vedeva una Sicilia con un reddito annuo pro-capite di 1.972 euro, una speranza di vita di 34 anni, un tasso di alfabetizzazione del 13%, il 52% della popolazione sotto la soglia minima di povertà, il 74% di lavoro minorile. Nel periodo 2001-2011 l’Isola presenta un reddito annuo pro-capite di 18.083 euro, una speranza di vita di 81 anni, un tasso di alfabetizzazione del 97%, il 9% di popolazione sotto la soglia minima di povertà, il 6% di lavoro minorile.
In mezzo ci stanno le trasformazioni socio-economiche partite con i moti del 1812 e culminate nel 1911. Il valore aggiunto del manifatturiero nel 1871 era, in Sicilia, l’1,02%, cioè più del totale italiano (1%). Il tasso di mortalità infantile era sceso dal 220 per mille del 1871 al 163 per mille del 1911; le iscrizioni alla scuola elementare erano salite dal 10% del 1871 al 53% del 1911.
Poi il binomio fascismo-guerra, che concentrò la produzione bellica al Nord puntando al Sud solo su una produzione agricola per il mercato interno, provocò il tracollo industriale ed economico del Mezzogiorno, che durò fino al 1951, quando il Pil pro-capite risalì fino al 3,4% rispetto al 2,6% del Centro Nord.
Fu nel periodo 1951-1975 che le politiche nazionali favorevoli alla crescita del Sud consentirono alla Sicilia di conoscere una forte industrializzazione e di recuperare in buona parte il divario con il Nord, facendone un’area nella quale era conveniente investire. Nel 1977 gli occupati nel settore manifatturiero erano 72.528, di cui il 58,5% dipendenti di grandi gruppi (42.448), il 30,2% di aziende pubbliche (21.919), il 24,2% di aziende private (17.526) e ben il 4,1% di società estere (3.003). Gli altri 30.080 lavoravano per imprese di proprietà meridionale. Il tasso di alfabetizzazione raggiunse la quasi parità col Centro-Nord e nel 1971 l’aspettativa di vita superò i 71 anni, cioè il doppio rispetto a 90 anni prima. In quei 25 anni fu costruita la metà dell’attuale patrimonio edilizio e infrastrutturale.
A metà degli anni Settanta, a causa della crisi energetica, salariale e di finanza pubblica, i mutati scenari ebbero due diversi effetti: nel Nord la forza lavoro espulsa diede vita a nuove piccole imprese; al Sud e in Sicilia, invece, il crollo della competitività, dell’export e dell’occupazione si associò a clientelismo, corruzione e criminalità. Il progressivo decentramento dei poteri ha poi reso le politiche più permeabili alle influenze delle pressioni locali. La diffusione della criminalità organizzata oggi toglie in media 15 punti percentuali al tasso di crescita economica e incide per l’8,1% sui sistemi produttivi locali, mentre la corruzione e gli altri crimini contro la pubblica amministrazione influiscono per il 251%.
Nel 2009 in Sicilia l’industria incide per appena l’8,9% del Pil, mentre il settore pubblico “produce” ben il 29,5%. I tempi di realizzazione di un’opera pubblica sono saliti dai quasi mille giorni del 2000 ai quasi 1.500 giorni del 2007.
Sintesi dei dati presentati da Guido Pescosolido
Al momento dell’Unità d’Italia il divario Nord-Sud non era tanto marcato, era invece profondissimo a livello europeo: infatti, la produzione siderurgica italiana era di 30 mila tonnellate a fronte delle 300 mila di quella inglese. Il divario del Pil nella fase unitaria era del 10 per cento, anche se poi il Nord dimostrò subito una diversa capacità industriale rispetto al Sud.
In quella fase storica vi erano 1.800 km di ferrovie al Nord e 100 km di ferrovie in Campania, zero in Sicilia e in Calabria. Su 300 comuni siciliani, solo in 80 vi erano strade carrozzabili. L’analfabetismo era dell’80% in Sicilia e del 50% al Nord.