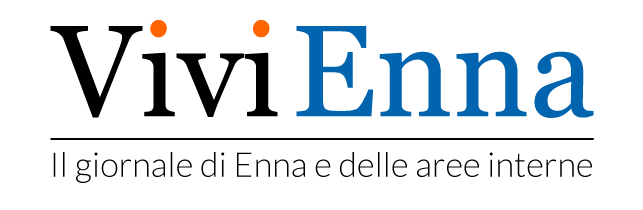Presentato ad Enna il calendario storico dell’Arma Carabinieri 2020
Enna-city - 15/11/2019
 L’edizione del 1991 proponeva in copertina Il Carabiniere a cavallo di Salvatore Fiume, un trionfo di rosso che evoca il sangue di tanti sacrifici. L’artista siciliano lo aveva realizzato nel 1972; la tela, di notevoli dimensioni, è custodita in una caserma dell’Arma di Milano. Altra edizione iscritta nell’Olimpo della pittura fu quella del 1986, con il volto di un carabiniere che sembra voler proteggere chi lo osserva. Lo aveva disegnato Pietro Annigoni, il ritrattista dei grandi della terra. A più riprese l’arte ha abbellito la nostra pubblicazione, dalle tavole di Ninni Verga e Klaus Wagger a quelle affidate due anni fa a Ugo Nespolo.
L’edizione del 1991 proponeva in copertina Il Carabiniere a cavallo di Salvatore Fiume, un trionfo di rosso che evoca il sangue di tanti sacrifici. L’artista siciliano lo aveva realizzato nel 1972; la tela, di notevoli dimensioni, è custodita in una caserma dell’Arma di Milano. Altra edizione iscritta nell’Olimpo della pittura fu quella del 1986, con il volto di un carabiniere che sembra voler proteggere chi lo osserva. Lo aveva disegnato Pietro Annigoni, il ritrattista dei grandi della terra. A più riprese l’arte ha abbellito la nostra pubblicazione, dalle tavole di Ninni Verga e Klaus Wagger a quelle affidate due anni fa a Ugo Nespolo.
Stavolta ospitiamo con gioia un altro artista di rilievo internazionale, considerato fra i massimi autori del nostro tempo.
Importante esponente della Transavanguardia, accolto in esposizioni da New York a Pechino, a Londra e Bruxelles, Mimmo Paladino è un’icona del fervore artistico che attraversa lo Stivale dall’epoca più antica. È il solco di Piero della Francesca, alla cui produzione egli si richiama esplicitamente, al punto che mentre scriviamo, nella splendida Arezzo che custodisce il ciclo della Vera Croce, è in corso la mostra La regola di Piero, omaggio di Paladino al grande pittore-umanista rinascimentale.
La lezione estetica del passato è evidente nella copertina, che riprende l’oro dei Maestri senesi e dei mosaici di Ravenna, tanto cari a Gustav Klimt. Un fondo oro che, soprattutto, intende celebrare il centenario di un prestigioso riconoscimento, la concessione della prima Medaglia d’oro al valor militare alla Bandiera dell’Arma, il 5 giugno 1920, per il contributo fornito alla vittoria nella Grande Guerra. Le tavole pittoriche a seguire illustrano l’attualità del quotidiano eroismo di tanti appartenenti all’Istituzione. La pagina centrale si ispira invece alla carica di Pastrengo del 1848, quando un drappello di Carabinieri a cavallo salvò il Re Carlo Alberto in battaglia. In coda, la tradizionale rassegna delle ricompense, ulteriormente arricchitasi nel 2019, suggello di un tempo trascorso fattosi presente, affinché il retaggio storico rimanga sempre sullo sfondo dell’oggi e nella prospettiva del domani. Alla pittura affianchiamo quest’anno una letteratura con la maiuscola, con brani che sintetizzano mirabilmente episodi di vita vissuta dei nostri reparti, nei quali si manifestano la solidarietà, l’umanità, la vicinanza alla gente, valori che devono sempre ispirare l’operato di ogni buon Carabiniere. I testi sono firmati da Margaret Mazzantini, una delle voci più alte della narrativa europea, che con i suoi romanzi, tradotti in trentacinque lingue, ha vinto fra gli altri i premi Strega e Campiello, affascinando milioni di lettori.
Se Mimmo Paladino dipinge le emozioni, Margaret Mazzantini le incide con il bisturi della sua scrittura affilata, misurata e incisiva. Insieme ci consegnano un ritratto dell’Arma contemporaneo, che rivela un dato importante: non siamo cambiati. Al netto delle differenze d’epoca, i fatti qui illustrati assomigliano molto a quelli delle copertine della Domenica del Corriere, a cui Beltrame e Molino ci avevano abituati.
È questo il motivo dominante del Calendario 2020: evidenziare la premurosa attenzione che ogni componente dell’Arma pone nei confronti della vulnerabilità, declinata nelle multiformi espressioni offerte dalla realtà quotidiana. Ed evidenziarla per il tramite della straordinaria espressività artistica di un grande pittore e di una grande scrittrice, a simboleggiare un impegno che nasce nella Storia, si alimenta del passato, vive nel presente, si proietta nel futuro. La nostra più intima vocazione, quindi, qui proposta nelle forme della contemporaneità per sottolineare la perdurante essenza della missione istituzionale.
Non sono infatti cambiati i compiti d’istituto né le istanze dei cittadini, che all’Arma chiedono attenzione, impegno, disponibilità ad assisterli non solo quando subiscono un torto, ma anche per le mille questioni che meritano semplicemente un consiglio, un conforto, una mano sulla spalla che è spesso quella del Carabiniere, dunque dello Stato.
Nemmeno può cambiare lo spirito: l’abnegazione che fa guardare al prossimo prima che a se stessi, quel riconoscere nell’altro un fratello che è la base per compiere al meglio il proprio dovere. Decine di migliaia di carabinieri hanno onorato la loro uniforme nell’anno passato: in silenzio, generosamente, sentendo nel proprio intimo di non fare alcunché di speciale. Un silenzio operoso più forte di ogni strepitio. Dedico a loro questo oggetto d’arte che ne ornerà le case e gli uffici. Con un pensiero particolare ai Caduti, che hanno pagato quell’onore al prezzo della vita.
GENNAIO
In servizio alle quattro del mattino, Roma dorme come una grande bestia placida. Ce ne stiamo nella nostra gazzella a vegliare l’acquario notturno, bagnati da qualche luce residua, un gabbiano atterra su un cassonetto con un garrito doloroso. Arriva la chiamata dalla Centrale Operativa, il nostro vecchio cuore pulsante, che non si ferma mai. Una segnalazione anonima, tre figure sospette avvistate sotto un palazzo popolare in zona San Giovanni. Siamo i più vicini, spetta a noi “convergere” sul posto, come diciamo in gergo. Si può correre, la tangenziale è deserta. Sfioriamo le armi nella fondina, ci serviranno? Durante gli anni di formazione ci hanno insegnato ad usare l’arma solo in caso di pericolo vitale, il problema è che spesso intuisci di aver rischiato la vita troppo tardi. Le barzellette dicono che i carabinieri non hanno un buon intuito, ridiamo anche noi. È bello ridere di se stessi. Il fatto è che l’intuito spesso non basta, quando prima di te stesso cerchi di salvare un altro. Ci vorrebbe la mano di Dio, ma quella spesso è distratta. Roma è troppo grande. Ci siamo noi, qualcuno più coraggioso, qualcuno che il coraggio lo vorrebbe in prestito da un superiore. Io credo di avere sempre paura, ho un ragazzo giovane in servizio, accanto a me, a occhio e croce potrebbe essere mio figlio. Abbiamo parlato un po’, ha una sorella che si sposa il mese prossimo, al sabato gioca a calcetto. Coprimi, gli dico, ha gli occhi sbarrati, annuisce. Sento la sirena di una gazzella di supporto che si avvicina. Il malvivente è in cima a una tubatura, i complici lo aspettano di sotto. Vedo armi da scasso, ma non da fuoco, almeno così sembra, c’è poca luce. Provano a scappare, li rincorriamo. Sono terrorizzati anche loro, hanno sacche di refurtiva che abbandonano nella corsa, ne prendo uno per la collottola. Ladruncoli, tanti ne raccogliamo, come frutti malandati, li vedi piegarsi sui sedili, prendersi la testa tra le mani. Penso alle loro madri, da qualche parte stanno dormendo in questa città, verranno svegliate da una telefonata. Da un piano terra, si solleva una tapparella, un odore buono di caffè, come quello che sentiamo a casa al mattino. Ci viene incontro una donna, una faccia anziana, una vestaglia, una testa scarmigliata, ragazzi lo prendete un caffè? Non possiamo fermarci in servizio, signora. Neanche per un caffè? È lei che ha chiamato la Centrale, e adesso ci chiede scusa per averci disturbato. È il nostro dovere signora. È buono il caffè? È molto buono, grazie.
FEBBRAIO
Ci pensavamo a quegli animali, dopo le nevicate dei giorni precedenti. C’era l’urgenza degli umani, le strade interrotte, i tetti crollati nei casolari, le tubature ghiacciate. Della sofferenza della natura si parla troppo poco, ma per noi pescaresi, la Riserva di Monte Corvo di Popoli, è un luogo dell’anima, nella geografia del nostro territorio appartato, produttore di solitudine. La bufera sembrava essersi placata, un pallido sole penetrava il cielo bianco. Forza, dissi, andiamo da loro, dagli animali. Da giorni erano isolati dal gelo, senza cibo, i loro rifugi naturali distrutti. La sensazione acuta di una disparità, una lontananza difficile da raggiugere. Strade accidentate e invisibili, nuvole cariche toccavano terra, sembrava di avanzare nel latte. La forza distruttrice aveva sovvertito l’ordine naturale delle cose. Le jeep scivolavano come sommergibili in quel fondale straziato. Neri speroni di alberi affioravano dal ghiaccio, le chiome abbattute sembravano donne in preghiera. Pensai a mia nonna, era lei che mi portava nel bosco da bambino, pensai alle castagne cotte nel tegame in cucina. Quando ci fermammo la neve mi parve una immensa bara bianca. Nessun rumore di vita, nessun canto, né dal cielo, né dalla terra. Poi un bramito improvviso, comparve il primo muso, quello di un cervo. Forse era l’unico superstite, ci fissava e il suo stupore era il nostro. Le grandi corna ornamentali scolpite sulla testa minuta. Aprì la bocca, come un bambino che sbadiglia nel sonno. Posammo del cibo nella neve. Mosse appena il collo. Ed ecco che dietro di lui, frusciando nel silenzio, comparvero a poco a poco gli altri compagni di bosco, daini, scoiattoli, gufi reali. Non erano spaventati, anzi sembravano aspettarci, ci vennero vicini con il fiato. In poco tempo ci trovammo circondati da quella che pareva una danza di ringraziamento. Gli occhi lucidi nel gelo, un calore interno che sempre ricorderemo, come un’esplosione di vita. Gli animali si mescolavano a noi, come quelli parlanti delle fiabe, un camoscio si appoggiò al cofano della nostra jeep e rimase lì a scaldarsi. Scattammo qualche fotografia e non ricordo una felicità più grande. Forse ho salvato qualche vita umana nei miei anni di servizio, ma salvare un animale è diverso, è come abbracciare la natura intera, qualcosa di primordiale e puro che ci appartiene ma che ci è stato strappato.
MARZO
Anche io credo di aver parlato con il sole, stordita, nelle nostre missioni, dall’Afghanistan alla Somalia, credo di avergli chiesto clemenza, per me e per i miei compagni, ma soprattutto per quelle persone maltrattate dai confini geografici. Quante volte devo averci pensato alla fortuna di essere nata in Italia piuttosto che in qualche striscia di deserto insanguinato. Figure umane che non dimenticherò, donne e bambini, storti, malnutriti, lingue nere sotto il sole radente e bruciante, maestoso e crudele, figure come figurine di un presepio tragico e scostante. Eppure sono qui, ancora una volta, in missione. Non riesco a restare lontana da questo sole così diverso dal nostro. Il sole di Gerico è davvero indescrivibile, l’energia solare sembra creare un movimento, le cose fluttuano in una intimità dorata che sembra voler risarcire la terra. Sono qui insieme alle mie compagne, nella nostra missione di training, addestriamo giovani poliziotte palestinesi. Ragazze toste, silenziose, sospettose forse. Osservano i nostri gesti con occhi ben aperti, li ripetono disciplinatamente. Forse temono di essere giudicate. Siamo diverse, straniere, loro vivono immerse nella Storia, in una realtà molto più drammatica della nostra. Nella loro forza e abnegazione, riconosciamo un comune, profondo, senso di appartenenza. Al tramonto, quando il sole fa il suo giro miracoloso lasciando scie di polvere rosata, ci togliamo il peso degli scarponi, il carico del dovere, e ci ritroviamo a ridere come ragazzine, senza altro distintivo se non quello del comune entusiasmo verso la vita. Timida viene fuori la verità, sono permalose perché, a differenza di noi, nessuna di loro sa ancora guidare. Si sentono menomate, avvertiamo un grido di rivolta, soffocato sotto le divise. Chiediamo al nostro comandante di autorizzare dei corsi di guida. Cominciamo a far tossire macchine ingolfate tra le dune, il rischio costante di finire contro quelle grosse palme che ci guardano dal cielo e quasi se la ridono di tutte queste donne pericolose al volante. Impararono tutte, rendemmo più completa la formazione militare delle nostre allieve, ma quelle ruote sulla sabbia segnarono qualcosa di più, la libertà ritrovata di tutte quelle ragazze palestinesi. Quando partimmo, e dall’alto vedemmo quella terra, a noi parve di aver piantato il seme radioso dell’emancipazione femminile sotto quel sole lancinante.
APRILE
Raramente si parla di Spinea. In linea d’aria la Serenissima Venezia è a meno di quattro chilometri, con il suo carico di turisti golosi di bellezza, da contemplare come in un salotto a cielo aperto, nel mare docile dei canali, dei gondolieri canori, delle mostre d’Arte, dei Palazzi Storici. Spinea invece è un’altra storia, un altro mondo, solo turismo povero, disgraziati scappati dalle loro terre. Il tessuto sociale è quello allentato delle periferie, certe strade sono cantieri di malaffare e noi carabinieri siamo sempre allertati. Quel pomeriggio pioveva, l’acqua risaliva dai canali di scolo, arrivò la chiamata di un addetto alla sicurezza di un supermercato, avevano fermato un extracomunitario intento a rubare. Ero insieme a un mio collega, anche lui padre di famiglia, e come uomini e come padri restammo muti, prigionieri di un dolore sconveniente per il nostro ruolo, quando ci trovammo davanti il malvivente: un bambino di dodici anni, che tremava e chiedeva perdono. Un’occhiata alla refurtiva sottratta, una manciata di penne e matite colorate, qualche quaderno. Facemmo il nostro dovere, interrogammo il malvivente. Quelle cose gli servivano per studiare, disse, la maestra aveva fatto l’elenco del materiale scolastico obbligatorio, ma i suoi genitori, rimasti entrambi senza lavoro, non potevano provvedere. Mi toccai il petto sotto la divisa, davvero il cuore mi doleva. Provai vergogna, come un uomo che si trova nudo suo malgrado. Sentivo bruciare dentro di me la paura del bambino, avrei voluto stringerlo contro la stoffa della mia uniforme per proteggerlo dal neon di quel supermercato. Il sabato prima ero andato con i miei figli a comprare astucci e quaderni. Anche il mio collega taceva, anche lui guardava il bambino come un insetto che qualcuno da lì a poco avrebbe acciaccato. Senza nemmeno dircelo cercammo il portafogli sotto la divisa e pagammo quel materiale scolastico. Rimanemmo ancora un po’ con lui, ci inginocchiammo sulla strada che odorava di marina sporca. Non devi rubare mai più, se in futuro hai bisogno di libri o di altri quaderni, chiamaci e noi interveniamo, a sirene spiegate! Riuscimmo a strappare un sorriso al suo piccolo volto pesto di vergogna. Almeno una volta al mese passiamo a trovarlo. Ciao Jamil, come va? Quest’anno ha passato l’esame di terza media con il massimo dei voti. Da grande voglio fare il carabiniere, ci ha detto. Il mio collega ha fatto una battuta, sei troppo intelligente per fare il carabiniere, ma Jamil non ha senso dell’umorismo. Voglio aiutare gli altri, ha insistito, minacciandoci con i suoi occhi scuri.
MAGGIO
A Ginostra il vulcano domina sul mare, come un gigante assonnato in posa dentro una cartolina. È una scintillante giornata d’estate sulla nostra motovedetta Monteleone, sotto le divise si fatica a resistere, verrebbe voglia di farsi una nuotata. Nessuno di noi si aspetta il boato che irrompe dallo scenario magnetico. È un attimo, un rigurgito violento atterrisce il mare, viscere terrestri si rovesciano in fiamme, una valanga di rocce impazzite e di lapilli cola lungo il fianco del vulcano. Il calore si solleva come fiato ardente. Gli yacht parcheggiati nelle calette mettono in moto e si allontanano. Dalla terraferma salgono le urla della gente in fuga che si riversa nel mare, come in una scena biblica. La Centrale ci segnala due turisti dispersi, stavano facendo una escursione sul vulcano, in un’area libera, a Punta dei Corvi. Uno è stato travolto dalla lava, ma l’altro è ancora lassù, raggiungibile solo via mare. Prendo il binocolo ma non vedo altro che fumo, la terra è inaccessibile come un inferno. Dal cielo salutiamo come una benedizione il Canadair della Protezione Civile che fa i suoi giri sopra al fuoco per domare gli incendi scaturiti dai lapilli. Ci tuffiamo in mare sotto una pioggia incandescente. Saliamo lungo una mulattiera, il calore è quello insopportabile di una fornace a cielo aperto. Camminiamo verso il sopravvissuto nella speranza di raggiungerlo prima che sia troppo tardi. È nero come una statua di fumo, ha inalato vapori tossici, è ferito e sotto shock, l’amico gli è morto tra le braccia. Non parla italiano, ma la disperazione è un lamento universale, comprensibile a chiunque. Ascoltiamo quelle parole in portoghese, che sembrano un lamento ancestrale, piange, le labbra disidratate tremano come spugne corrose. Ha il corpo insanguinato, bruciato, sembra il superstite di una guerra, ci guarda e ancora non sembra aver realizzato cosa sia accaduto, continua a ripetere il nome dell’amico. Dobbiamo allontanarci in fretta da quel luogo minaccioso che ancora ribolle. Riusciamo ad imbarcarlo sulla Monteleone e a dargli i primi soccorsi, mentre il Capitano si dirige in una zona più sicura. A bordo il ragazzo sembra riconoscere qualcosa, i nostri volti, alcuni giovani come il suo. Adesso sei in salvo, gli dico, e stavolta la salvezza è arrivata dal mare. Ma anch’io sto pensando al suo amico, a quel corpo carbonizzato che abbiamo lasciato indietro, vorrei chiedergli scusa per non essere riuscito a portare in salvo anche lui.
GIUGNO
Bisognerebbe non farlo, lo so, la partecipazione emotiva non dovrebbe mai oltrepassare la divisa, però è più forte di me, quando si tratta di un reato sessuale, l’indignazione che provo diventa dolore, qualcosa di ancestrale mi scuote, come se in me si sollevasse la ferita di tutte le donne violate. Erano mesi che con i miei colleghi tenevamo sotto controllo quel circolo in provincia di Napoli, frequentato da uomini all’apparenza per bene, un’indagine di routine, sfruttamento della prostituzione, il proprietario era un anziano noto nel giro dei locali notturni. Poi ricevetti la segnalazione di quel ragazzino, mi parlò della sua fidanzatina minorenne, voleva salvarla, negli occhi una sorta di panico. Ero preparata, sapevo a cosa andavo incontro la notte dell’irruzione. Eppure rimasi tramortita quando vidi quei corpi giovani, che si muovevano flebilmente come alghe perse in quel mare notturno e maleodorante, gambe magre come braccia, musi infantili bistrati come maschere. Riconobbi quel sentimento, di morte forse, vedevo con i miei occhi la carie del mondo, l’innocenza uccisa tra posaceneri colmi di cicche. Provai un disgusto, troppo profondo da digerire. Pensai a mia figlia, a quando al mattino si tirava il piumone sulla testa per restarsene nei sogni ancora un po’. Chiusi gli occhi, poi li riaprii. Mi avvicinai a quella che sembrava davvero un uccellino avvilito, Tamara, romena, sedici anni. Non voleva parlare, si guardava intorno come cercando la mano che di lì a poco l’avrebbe uccisa. Le braccia erano ferite, cicatrici di sigarette spente nella carne. Le dissi che non aveva più niente da temere, l’avrei portata in un posto protetto. Non mi credeva, lo sguardo sfacciato e cupo dei bambini traditi. Quando le dissi che ero una mamma, finalmente mi guardò, come se in quel degrado una immagine salvifica fosse tornata a farle visita, vidi una luce, qualcosa di sacrale in quel muso sudicio. Cominciò a raccontarmi di sua madre, era malata, le mandava soldi ogni mese a Timisoara, quei pochi che le lasciavano tenere. Mi chiese una sigaretta, le risposi di no, come avrei fatto con mia figlia. Sei troppo piccola per fumare, era davvero assurdo negarle una sigaretta in quella fogna, ma mi venne spontaneo farlo. Accettò quel rifiuto con un sorriso triste, che nascondeva un pensiero docile. Grazie mamma, disse. Ci allontanammo tenendoci per mano.
LUGLIO
In verità, chi ci pensava più a quel corso di pronto intervento, a quel bambolotto simulatore, a quelle manovre, non ricordavo nemmeno di averlo fatto. Era un pomeriggio di svago, senza divisa, camminavo in jeans accanto a mia moglie in un centro commerciale. Le urla arrivarono inaspettate, sembrava il rantolo di un animale ferito a morte. Mia moglie lo sa, mi prende in giro, sei sempre in servizio, dice, non ti rilassi mai, osservi il mondo come se dovessi sempre stanare un pericolo. Salto la folla, mi abbasso sul marciapiede, sotto una vetrina di televisori accesi, un bambino giace inerte, sembra piccolissimo. Le urla sono quelle della madre, quelle di una bestia scuoiata. Il figlio improvvisamente ha smesso di respirare dopo una crisi di pianto. Il corpo è piccolo, come farò a trovare il cuore? Ma non penso, agisco. Uno, due, tre, comincio a praticare il massaggio cardiaco, non sono sicuro di ricordare. Invece ricordo, sono al parossismo, la calma è impossibile eppure è necessaria. Le costole sembrano paglia di un cestino. La folla è dietro di me, compresa mia moglie che vorrebbe fuggire per non vedere quella scena. Non ce la farò, penso, non ce la sto facendo. Devo farcela. Urlo a qualcuno di chiamare il 118 mentre mi avvicino alla bocca, stringo le narici, insufflo l’aria, come ho fatto con il bambolotto simulatore. La bocca è calda e il bambino è sudato. Sono teso, concentrato, il panico mi guida senza distrazioni, dalla bocca al cuore, alternando le due pratiche vitali. Mi hanno detto che è durato pochi minuti, io credo di aver vissuto in quei pochi minuti un tempo più esteso di una vita, ho visto molte cose, mi sono sentito solo al mondo, abbandonato da tutto e tutti, solo con quel bambino. Francesco si chiama, mi sono rialzato, ho sentito il vecchio rumore dei legamenti rotti durante un’esercitazione, ho detto sono io, sono le mie ginocchia, potrò raccontare questa storia infinite volte, tremando di felicità, intorno il mondo era un po’ sfuocato e ci ho messo un po’ per tornare presente.
AGOSTO
Non capita spesso il privilegio di poter andare in ricognizione a piedi, tra una comunità tranquilla che ti saluta con affetto, ma Sant’Ilario d’Enza è un piccolo paese dove le giornate seguono una pacifica routine. Quel mattino di maggio restammo sconcertati, quando sentimmo un lamento strozzato che sembrava giungere dal cielo. Sulle prime pensai al grido di un uccello. Fu il collega ad indicarmi la donna anziana in alto, aveva scavalcato il balcone delle propria casa, i piedi scalzi, un solo braccio aggrappato alla ringhiera. Un’immagine dolorosa, davvero inaspettata in quel contesto mite. Signora come sta? Come si chiama? Dal basso non sembra udirci, il balcone è quello dell’ultimo piano, la donna è confusa, forse un po’ sorda. Il portone per fortuna è aperto. Saliamo le scale di corsa, saltando a mucchi i gradini. Sul pianerottolo una donnina minuta agita le braccia, ci indica la casa dell’aspirante suicida. Con noi in servizio c’è Mario, il sorriso di un bambino, le spalle di un lottatore. È con quelle che sradica la porta. L’odore di un’intimità scoperchiata, un gatto che dorme sul divano. È un tentativo di salvataggio delicatissimo. Bisogna scivolare in silenzio, si pattina sulla crepatura sottile di un’emotività che potrebbe rompersi davanti alle nostre divise. I singhiozzi della donna sono strazianti come se avesse raggiunto un apice troppo difficile da sostenere. Il nostro brigadiere più anziano ha qualche chilo di troppo, ma in servizio può diventare una piuma, una leggerezza che gli deriva dal convincimento della propria funzione, credo. È lui che avanza soffice, afferra la donna di spalle, la cinge di colpo con entrambe le braccia e la tiene salda a sé. Lei si agita un po’, sembra una gallina spiumata, ma è solo forza residua, si accascia sfinita. Forse alla fine non voleva altro che essere salvata e tenuta stretta. Il brigadiere la tiene in braccio come una sposa e lei si lascia riportare dentro con una certa solennità. Resta sul divano accanto al gatto, ci chiede scusa infinite volte, dice che si vergogna tanto, che è stato solo un momento. Le strofino una gamba come faccio con mia madre in ospedale. Gli anziani hanno bisogno di parlare, il silenzio logora, quei pensieri reiterati nella testa che nessuno ascolta. Ho studiato psicologia prima di entrare nell’Arma, forse so fare le domande giuste, ma soprattutto so ascoltare. La signora parla, racconta la sua vita triste, è sola, è malata, la pensione non basta per sentirsi decente. Mario, è alto quasi due metri, si abbassa, un armadio che diventa un comodino, stringe quel sacchetto d’ossa con un trasporto infantile. Figlio mio, figlio mio…
SETTEMBRE
In clausura in quella stanza con le tapparelle tirate giù, non era certo un bel lavoro, mi sentivo la febbre addosso fissa, brividi che si infilavano sotto gli abiti. Fissa lì davanti ai monitor, quelle scatole luminose accese in contemporanea, gli occhi che vagano da uno schermo all’altro. Ti alzi per sgranchirti le gambe, quando qualcosa di colpo si muove. Di colpo ti siedi, con quel fremito, un dolore al basso ventre, come un trauma residuo che si risveglia. Hai bisogno di vedere qualcosa per poter intervenire, ma dentro di te preghi che nulla accada. Sei costretta a sorbire quei monitor che ti mettono a disagio, devi oscurare una parte di te. Anche tuo figlio è andato all’asilo, ha avuto delle maestre eccezionali, te ne ricordi una, calda e profumata come una pagnotta di pane appena sfornata. C’è una donna che le somiglia, si muove in quei monitor assieme alle altre. È lei che colpisce, una manata su un volto molto più piccolo della sua mano, la stessa mano che afferra la testa per i capelli, la scuote, la trascina. Basta così, i monitor hanno registrato. Siamo già in macchina, facciamo irruzione nella scuola, entriamo nella classe, e adesso i bambini, quei puntini nel monitor, sono lì, più o meno nella stessa posizione, con i loro golfini colorati, il loro moccio. Uno scenario presente e vivo. Le maestre non sembrano nemmeno rendersi conto della gravità delle loro azioni, hanno volti strani, come animali abbagliati dai fari di un’auto. Non abbiamo fatto nulla, vogliamo bene ai bambini. I bambini guardano curiosi le nostre divise. Il mio collega si avvicina al bambino che ha subito l’assalto, se ne sta lì piegato, la testa reclinata come un fiore moscio su un gambo. Ciao amore, come stai? Mi fai vedere il disegno? Bravo, che bello. Lo prende in braccio, lo solleva, non pesa nulla. I nostri occhi s’incontrano, lui annuisce, io annuisco, le difese sono crollate. Ci sbrighiamo a ricacciare indietro le lacrime prima che si vedano, è un comando muto che ci diamo vicendevolmente. I monitor nella sala operativa sono spenti, attendo il momento in cui si riaccenderanno, quando dovrò ancora una volta restare seduta al mio posto. Ma stasera sono serena mentre prendo il cappotto, saluto i colleghi e torno a casa dalla mia famiglia.
OTTOBRE
Era dicembre, sul lungomare di Rimini erano già state montate le luminarie, oltre trenta chilometri di superficie coperta di luci. Alla Centrale Operativa arriva una chiamata, una voce maschile trafelata: sto provando a chiamare mio padre da diverse ore, ma non risponde, è disabile, fermo in un letto. L’uomo è lontano da Rimini per lavoro, ha un problema alla macchina, sembra disperato. La catena di comando si mette subito in azione, l’intervento è affidato alla nostra pattuglia. Il comandante ci raccomanda di fare in fretta. Il quartiere di Viserba è piuttosto lontano, le strade formicolano di traffico, sono tutti in giro per fare acquisti. Nella nostra pattuglia è sceso quello speciale silenzio, un’allerta interiore che ci tiene concentrati e sospesi: una vita in pericolo, una delle tante, ma per noi in quel momento è l’unica da raggiungere. Suoniamo inutilmente il campanello, dall’interno nessun rumore, usiamo le spalle per buttare giù la porta. Una casa modesta e ordinata, un odore stagnante di sudore e medicinali. Il letto è vuoto, l’uomo è sul pavimento, immobile, il supporto della flebo rovesciato, sanguina dalla testa. Gli prendo una mano, sento il polso vivo, il mio collega si inginocchia accanto a me, gli carezza la schiena, gli sistema il pigiama sollevato su una piaga. Giuseppe siamo qui, ci senti? La testa insanguinata annuisce flebilmente. Lo solleviamo molto lentamente per non procurargli altri traumi. Stai tranquillo Giuseppe, non è niente. Lo stendiamo sul letto. Ecco fatto Giuseppe, tutto a posto. Si vergogna, sembra quasi chiederci scusa con gli occhi. Gli tengo una mano, guardo le vene scure, tribolate. Una mano antica. Sul comò lì davanti, un uomo e una donna giovani nella cornice di un matrimonio lontano. È tua moglie? Che bella coppia. Mi dice che è vedovo da molti anni, gli chiedo qualcosa della sua vita, voglio sentirlo parlare, voglio mantenerlo cosciente in attesa del 118, trema e il respiro è affannato. Ci ha chiamato tuo figlio, ti vuole tanto bene. Giuseppe ci guarda, cerca conferma nei nostri occhi, annuisce commosso. Arriva il soccorso medico, lo lasciamo ai sanitari. Non vorrebbe più lasciarmi la mano. Grazie figlio mio, sussurra. Fatico a staccarmi da quel letto. Da anni non sono più un figlio, mio padre non l’ho visto invecchiare. Era un uomo grande, allegro, se n’è andato quando ero ancora un bambino, gli hanno sparato a un posto di blocco. Ho preso la sua divisa, la sua impronta, ho preso parte del suo cuore, almeno così dicono.
NOVEMBRE
Resta il fatto che per noi della Stazione di Incisa Giovan Battista Scapaccino, caduto a trentadue anni per quel senso estremo del dovere che forse apparteneva a un’epoca antecedente, rappresenta un ideale ancora vivo. Ci sentiamo sollecitati davanti a ogni vita umana in difficoltà, così quando arrivò quella telefonata, che non ci segnalava reati, bensì il disagio di un’anziana, andai comunque di persona a verificare. La donna non usciva più di casa da mesi e tra quelle pareti anguste regnava la trascuratezza. Eppure era stata una donna attiva, vigorosa, una presenza storica della nostra comunità. Si guardava intorno smarrita, non mi voleva lì, come se io avessi interrotto qualcosa nel precipizio della sua solitudine. Forse provava vergogna. Quell’abbandono era la rappresentazione visibile della sofferenza psichica che la teneva prigioniera. Le dissi che non ero lì per giudicare, ma soltanto per aiutarla. Faticai, non si fidava più del mondo. Infine cominciò a parlare, con una voce che pareva uscita da un pozzo. La morte del marito, la tristezza che l’aveva seppellita viva in quella inettitudine di continuare a fare anche i gesti più semplici. Convocai in caserma i parenti più prossimi, feci loro una doverosa strigliata. La signora aveva urgenza di cure mediche e bisognava subito mettere mano a quella casa fatiscente: finché fosse vissuta in quelle condizioni, non avrebbe mai ritrovato lo spirito per ristabilirsi dal deperimento. Con una scusa riuscii a far allontanare la donna per qualche giorno, il tempo necessario per ripulire quell’alloggio indecoroso. La mattina in cui la riaccompagnai a casa, la signora varcò la soglia e camminò quasi in punta di piedi: era strabiliata, respirava l’odore della vernice fresca, guardava quelle stanze rinnovate come se non credesse ai suoi stessi occhi. Adesso comincia una nuova vita per te, dissi. È una reggia, sussurrò. Annuiva, fiera della sua casa che adesso riconosceva, come forse riconosceva se stessa dopo tanta deprivazione. Mi sembrò che quella pulizia si fosse portata via anche tanti brutti ricordi. La signora mi strinse con mani ossute e vitali. Adesso mi sento davvero una regina, Maresciallo. Mi avete restituito qualcosa di grande, qualcosa che avevo nel petto, ma che avevo perduto, come una collana di perle che si rompe e i grani se ne vanno dappertutto. Parlava della dignità, che rappresenta il fondamento della condizione umana, quel rispetto che ognuno deve avere verso se stesso, ma che non sempre è possibile. Noi lavoriamo anche per questo.
DICEMBRE
Indelebilmente ricordo quei giorni, il terremoto solleva un sentimento antico, panico, una memoria che appartiene a tutti, perché tutti apparteniamo a questa terra posata su un costato fragile. Spesso restavamo in silenzio nel nostro ufficio arrangiato per l’emergenza in quel capannone di Città Ducale, un luogo che era diventato una specie di mensa delle anime, un centro di aggregazione per i cittadini superstiti. Accompagnavamo gli sfollati davanti alle loro case. I più fortunati riuscivano a recuperare qualcosa, gli altri guardavano soltanto le macerie, annuivano come per convincersi che fosse davvero accaduto. Cessate le sirene delle ambulanze, a noi toccava l’azione dolorosa del rinvenimento della memoria, le divise impolverate dalla calce degli edifici andati giù, i berretti tolti per asciugare il sudore in quell’avvilimento. Una mattina ci venne a far visita un uomo, il passo delicato di un’ombra. Piangeva la moglie con lacrime grosse come biglie. Era morta di malattia, nel suo letto, poco prima del terremoto, ed egli quasi sorrideva, perché almeno non le era toccato lo sconquasso. Ci disse che era una pittrice, dipingeva quello che aveva nell’anima, i colori le avevano fatto compagnia fino alla fine dei suoi giorni. Lui era rimasto solo con tutti quei quadri, un testamento artistico che aveva voluto rendere pubblico per far conoscere ai conterranei il senso intrinseco di quel passaggio sulla terra. Con tanta volontà, era finalmente riuscito ad allestire una mostra al Museo Civico di Amatrice, ed ecco che in quella notte d’agosto tutto era finito. Avevamo compiti più gravi, però quel racconto ci commosse. Scavammo in quello che restava del museo. Dopo quasi due settimane riuscimmo a salvare buona parte delle opere. Le portammo nel nostro capannone, e allestimmo una specie di mostra lì. Le persone che entravano si fermavano davanti a quelle tele in rispettoso silenzio, guardavano quei volti, quei paesaggi dipinti che forse non esistevano più. Non scorderò mai il volto segnato di quel vedovo che sfiorava le tele, come se toccasse il corpo stesso della moglie e ci benediva quasi avessimo compiuto un miracolo. Queste tele senza dubbio valgono poco nel mercato dell’Arte, ci disse, ma adesso che le guardo, e penso alla fatica che avete compiuto, senza alcuna ragione, se non quella del cuore, io vedo un grande capolavoro di umanità.
Margaret Mazzantini
RICOMPENSE CONCESSE ALL’ARMA DEI CARABINIERI DAL 1814 AL 2019
ALLA BANDIERA
6 Croci di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia
MEDAGLIE D’ORO
3 al Valor Militare
3 al Valor dell’Esercito
10 al Valor Civile
7 al Merito della Sanità Pubblica
5 ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte
2 ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte
2 ai Benemeriti dell’Ambiente
1 di Benemerenza per il terremoto del 1908
6 al Merito Civile
1 di Benemerenza per il terremoto del 2009
MEDAGLIE D’ARGENTO
5 al Valor Militare
1 al Valor Civile
MEDAGLIE DI BRONZO
4 al Valor Militare
CROCI DI GUERRA
2 al Valor Militare
INDIVIDUALI
53 Croci di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia
MEDAGLIE D’ORO
121 al Valor Militare
2 al Valor dell’Esercito
1 al Valor di Marina
27 al Valore dell’Arma dei Carabinieri
176 al Valor Civile
81 al Merito Civile
26 al Merito della Sanità Pubblica
2 ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte
9 ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte
5 ai Benemeriti dell’Ambiente
131 di Vittime del terrorismo
MEDAGLIE D’ARGENTO
3168 al Valor Militare
16 al Valor dell’Esercito
22 al Valor di Marina
57 al Valore dell’Arma dei Carabinieri
2245 al Valor Civile
61 al Merito Civile
25 al Merito della Sanità Pubblica
37 ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte
10 ai Benemeriti dell’Ambiente
MEDAGLIE DI BRONZO
5732 al Valor Militare
14 al Valor dell’Esercito
42 al Valor di Marina
30 al Valore dell’Arma
dei Carabinieri
3576 al Valor Civile
216 al Merito Civile
47 al Merito della Sanità Pubblica
132 ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte
2 ai Benemeriti dell’Ambiente
CROCI
3616 Croci di Guerra e Croci al Valor Militare
22 Croci d’Onore alle Vittime di atti di terrorismo all’estero