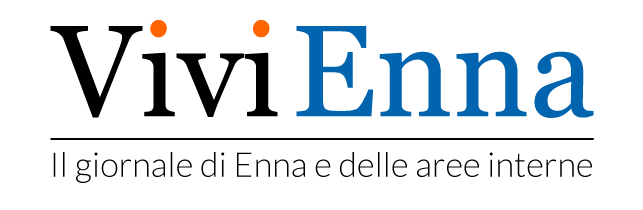L’Italia di fango e la lezione di Niscemi che non vogliamo imparare
Comunicati Stampa - 31/01/2026
REGALBUTO – C’è un copione stanco e tragico che l’Italia recita ciclicamente, una sceneggiatura che non conosce confini geografici e che, nel gennaio del 2026, ha trovato in Niscemi il suo ennesimo palcoscenico drammatico. Dopo il passaggio del ciclone e la ferita aperta dalla grande frana, quel che resta sul terreno non è solo fango e detriti, ma la radiografia impietosa di un Paese fragile. Un territorio trascurato, violentato e dilapidato al punto da aver perso ogni difesa immunitaria contro la furia degli elementi.
Guardando le immagini che arrivano dalla Sicilia, la tentazione del “già visto” è forte, così come è forte l’abitudine, tutta italiana, di cercare il capro espiatorio facile. Quando la terra trema o scivola al Sud, si sprecano i richiami alla mala politica locale, all’abusivismo, all’ombra lunga delle mafie. Luoghi comuni rassicuranti per chi guarda da lontano, utili a circoscrivere il male in un recinto specifico per sentirsi assolti. Ma la verità che emerge da Niscemi è ben più scomoda: non c’è differenza tra Nord e Sud, tra Regioni virtuose e non, quando si parla di dissesto idrogeologico. L’Italia intera è un gigante dai piedi d’argilla, lasciato in balia delle onde senza alcuna difesa strutturale.
Il caso di Niscemi è, in questo senso, l’archetipo del fallimento nazionale. Non siamo di fronte all’imprevedibile capriccio del destino, ma alla cronaca di un disastro annunciato e protocollato. La ferita della montagna era nota dal lontano 1997, quando una frana analoga sconvolse tre quartieri, costringendo intere famiglie all’evacuazione ed evidenziando in modo inequivocabile l’instabilità del versante. Dal 12 ottobre 1997 al gennaio 2026 sono passati quasi trent’anni. Trent’anni di carte bollate, di progetti forse immaginati e mai realizzati, di parole spese al vento.
Nonostante la conoscenza scientifica del rischio, la mancanza di interventi strutturali di messa in sicurezza ha preparato il terreno – letteralmente – per la riattivazione del movimento franoso. E qui crolla l’alibi della politica di parte. Nessuno, oggi, può permettersi di puntare il dito contro il governo di turno o l’amministrazione locale del momento per lavarsi la coscienza. Le responsabilità sono storicamente trasversali: destra, sinistra, centro, liste civiche. Colori diversi che si sono alternati alla guida del Paese e degli enti locali, uniti però da un unico filo conduttore: l’incapacità di passare dalla cultura dell’emergenza a quella della prevenzione.
La fragilità del territorio abbraccia tutta la Penisola, dalle Alpi agli Appennini, fino alle isole. Abbiamo costruito dove non dovevamo, abbiamo cementificato i letti dei fiumi, abbiamo disboscato i versanti che reggevano le nostre colline. E poi, puntuali come una sentenza, arrivano le piogge, i cicloni, e noi ci stupiamo. Lo stupore è forse l’aspetto più ipocrita di questa tragedia: ci meravigliamo che sia accaduto ciò che sapevamo sarebbe accaduto.
Niscemi oggi è il simbolo di un’Italia che ha smesso di curare se stessa. Se non comprendiamo che la difesa del suolo è la prima grande opera pubblica di cui questo Paese ha bisogno, continueremo a contare i danni e, Dio non voglia, le vittime. Non serve un altro “stato di calamità”, serve uno stato di coscienza. Perché la lezione ci è stata impartita decine di volte, dal Vajont a Sarno, da Messina a Ischia, fino a Niscemi. Il problema non è che non l’abbiamo capita; è che, con colpevole ostinazione, abbiamo scelto di non impararla.