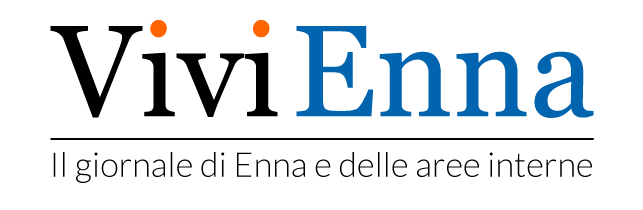Da convegno di Bagheria sulle pari opportunità il ritorno alla politica delle donne
Enna-Cronaca - 26/05/2011
Al convegno sulle pari opportunità, società, istituzioni e politica, svoltosi a Bagheria, organizzato dal dipartimento delle donne dell’UDC, con le relazioni di Giovanna Caldura, Antonella Russo, (rispettivamente responsabile regionale e provinciale del coordinamento pari opportunità UDC), Giusi Coniglio, Laura Bisso, Giovanna Benvenuto e gli interventi del candidato sindaco Vincenzo Lo Meo,di Andrea Piraino, Giulia Adamo, Vincenzo Galioto, Salvatore Lentini, ed il sen.Giampiero D’Alia, gli argomenti trattati sono apparsi attuali, orientati verso nuove e/o rinnovate prospettive.
Un convegno ricco di ripensamenti, riposizionamenti politici, di nuove opportunità di affermazione di valori culturali, umani, morali ed etici, che intendono approfondire e rivedere il ruolo dell’uomo e della donna nella società odierna che va riorganizzata verso obiettivi di servizi, che migliorino la qualità della vita, sia per l’essere umano come singolo, che come espressione micro-sociale in famiglia, ed, in senso più lato, come componente di maggiori aggregati socio-politici-istituzionali.Tali obiettivi hanno avuto un notevole impulso negli ultimi venti anni.
Oggi la società è cambiata e nuovi elementi, strutture e sovrastrutture la compongono e condizionano, la scompongono e la modificano di continuo; ma, in taluni aspetti, specie nel mezzogiorno, è rimasta bloccata, se non peggiorata.
Il grado di benessere raggiunto (ma anche le immense sacche di modesto sviluppo e di enormi povertà), le nuove scoperte, le innovazioni tecnologiche, la scienza e quant’altro (trasporti, comunicazioni, mass media, etc…), hanno condizionato e condizionano il pensiero umano, l’uomo e le sue passioni, le relazioni e l’organizzazione sociale.
Se prima la politica intendeva rappresentare i mega bisogni (quelli del produttore, del lavoratore, dell’impiegato, dei professionisti), spesso riuscendo a dare garanzie (redditi, previdenza e assistenza socio-sanitaria) ed esprimendo capacità di propulsione, di progetto e di mediazione, oggi sembra non avere più smalto, capacità di sintesi e di soluzione ai vastissimi problemi emergenti dalla società, dall’economia e dal lavoro, ma anche dai bisogni civici, civili e sociali che promanano dal territorio più piccolo al più esteso (rifiuti, salute, trasporti, infrastrutture, istruzione e formazione, inclusione sociale, ambiente e cultura).
Eppure le provviste finanziarie scaturenti dai finanziamenti, preordinati al soddisfacimento di quei bisogni, arricchiscono le casse statali e regionali in entrata e vi dimorano in attesa di essere impegnate e spese.
Oggi forse scontiamo la mancanza di una reale ed effettiva convergenza tra organizzazioni (statale, europea e regionale), non c’è un foedus se non a livello formale-normativo di vertice e non di pari dignità; manca una programmazione lineare, condivisa e coerente. Le politiche regionali di coesione languono e nel mezzogiorno d’Italia segnano il passo.
Spesso si elaborano, gestiscono, ed eseguono progetti, scollegati da uno sviluppo armonico di un determinato territorio, divenendo talora incompiuti per mutate esigenze socio-economiche del territorio medesimo: cioè mancherebbe una stabilità programmatoria, che non consente una spesa costante, progressiva e cadenzata secondo le regole comunitarie, che sono molto sensibili alla chiarezza e trasparenza delle azioni. Ostano talora politiche di tornaconto, un eventuale disallineamento tra amministrazione e gestione, a causa della presenza di meccanismi decisionali e procedurali non perfettamente messi a punto.
Probabilmente le regioni meno sviluppate devono subire una economia basata su mercati più competitivi, con cui non riescono a misurarsi neanche approntando una organizzazione della politica e delle istituzioni, che sia stabile, moderna e competitiva, che sia capace di organizzare le risposte ai bisogni e alle emergenze in tutte le sue articolazioni territoriali e di governo dei processi, che risolva eventuali criticità.
Per quanto ci riguarda, la riforma dell’amministrazione regionale era forse necessaria, ma i ritardi li sappiamo ormai tutti e ciò che essa ha prodotto e non.
La spesa dei fondi strutturali di alcuni paesi dell’est Europa ci ha superato e noi stiamo ancora a fare elaborazioni di alleanze politiche, cambi continui di casacca, leghe e controleghe, pensieri autonomistici, mentre i 18 miliardi di euro di contributi comunitari e statali sono stati utilizzati in minima parte (intorno al 13-15 % del totale assegnato).
Non abbiamo ancora maturato un vero e reale disegno riformatore, graduale e progressivo, intriso di un rinnovato senso di democrazia condivisa e moderna, libera, ma responsabile e giusta, interclassista e partecipata, che tende ad un benessere diffuso, alla tutela dei deboli e degli emarginati, a dare pari dignità agli essere umani nel lavoro, nella scuola, nella società in genere, a dare impulso al tessuto produttivo-imprenditoriale.
Di certo se il federalismo decolla può dare un supporto alle entrate ricavate direttamente dal territorio, ma può comprimere anche risorse e redditi disponibili, se non programmate con adeguate e razionali politiche fiscali territoriali, se queste non osservano i macroindicatori nazionali e comunitari, per cui occorre mettere in atto, opportunamente, una specie di camera di compensazione tra regioni ricche e povere, creando un apposito fondo redistributivo, rapportato agli eventuali fabbisogni regionali e territoriali.
Le azioni sono lente ed i ritardi accumulati sono notevoli. Occorre dare risposte e soluzioni con una nuova politica,ma tali obiettivi sono una scommessa molto rischiosa, nella considerazione che la politica deve tenere conto dell’attuale crisi recessiva e di stagnazione dell’economia internazionale, cui si sono aggiunte le turbolenze macroregionali dei popoli mediterranei, che insistono sulle zone nord-africane soggette ad un terremoto immigratorio che rischia di condizionare il pacifico sviluppo delle relazioni internazionali a sud dell’Europa ed il sottostante quadro di orientamento politico-economico-istituzionale ed anche sociale-religioso tra i popoli e gli stati mediterranei.
Quindi, mentre si ripensano nuove politiche nazionali, regionali e locali, la politica di oggi pare che abbia bisogno di offrire alla collettività e alle istituzioni un credibile e rinnovato ruolo di elaborazione, organizzazione ed azione programmatica, cui possano concorrere anche le componenti cattoliche e laiche delle nuove classi dirigenti, che sappiano ridare quell’imprimatur ciclico e duraturo, tipico dei grandi pensieri e movimenti politici.
Tali classi politiche devono sapere fronteggiare non solo la crisi e forse il degrado progressivo di una lunga ed estenuante stagione politica di sterili opposizioni di parte e di rallentamenti dell’azione, ma anche gestire le emergenze scaturenti dalle rotture dei normali rapporti internazionali a causa dei sommovimenti nord-africani che aspirano alla libertà e alla democrazia, ingiustamente soppresse nel corso della loro storia secolare.
Silvio Di Giorgio
sisaldi@alice.it