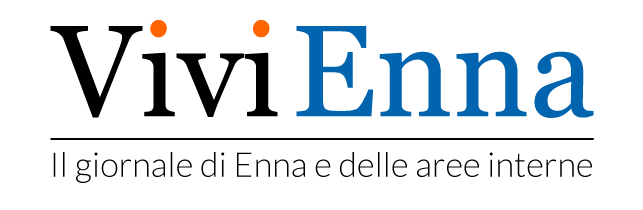Kore Enna. Puglisi: squarcio culturale tra Stato e università
Enna-city - 26/03/2013
Enna – “Guardo con orrore all’Italia dei prossimi trenta o quaranta anni, un’Italia nella quale ad invecchiare saranno i giovani di oggi, quelli inoccupati o disoccupati, che attendono un lavoro per versare i loro contributi assicurativi per la pensione, i quali diventeranno anziani in un Paese paurosamente povero, privo di mezzi per vivere e farli sopravvivere”. Così il Rettore della Libera Università degli Studi “Kore” di Enna, Giovanni Puglisi, in uno dei passaggi più accorati della relazione esposta stamani in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2012 – 2013 alla Libera Università degli Studi “Kore” di Enna.

Rettore Kore Giovanni Puglisi
Un pò un “fuori onda”, in deroga alla prassi e al galateo istituzionali: è così che Puglisi, tra l’altro anche Rettore dell’Università IULM di Milano e vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ha voluto definire il suo intervento, nel corso del quale ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme rispetto allo scollamento ormai insanabile tra le Università italiane e la vita politica del Paese. “L’Università italiana, statale e non statale in particolare, non sembra più appartenere a questo Paese, preoccupato principalmente – ha tuonato Puglisi – di controllarne i conti, piuttosto che di misurarne la capacità e le performance scientifiche e formative. Il fascismo privò l’Università della sua libertà di insegnamento; il post-fascismo dei nostri giorni sta privando l’Università, la scuola, la ricerca, in una parola la cultura, del diritto di sopravvivenza, affidandola ad una eutanasia guidata tragicamente irreversibile”.
Accuse precise, forse ancor di più quelle relative alla situazione delle Università siciliane, “dove il sistema autonomistico ‘speciale’ – ha affermato il Rettore – ha finito con il diventare da privilegio costituzionale castigo quotidiano, consegnando la nostra Sicilia al suo più triste primato: non c’è, infatti, regione al mondo in cui la mafia ha decapitato tutte – dico tutte – le istituzioni”.
“Le Università in Sicilia – ha denunciato Puglisi – sono quasi figlie di nessuno: lo Stato centrale le considera alla stregua delle altre. A sua volta, la Regione Siciliana, affogata dalle difficoltà finanziarie e dalle pressioni sociali ed economiche della crisi gravissima che attraversa tutta l’economia isolana, non mi sembra le abbia messe al centro delle proprie attenzioni, né fra le prime priorità della sua agenda legislativa e di Governo. Dimenticando che in queste aule si costruisce la Sicilia del futuro, quella che potrà garantire ai giovani di oggi e di domani la dignità di vivere da cittadini onesti e l’orgoglio della propria identità insulare”.
 Il Rettore dell’ateneo ennese non ha risparmiato considerazioni al vetriolo “sul tema del Potere, del suo uso e, ahimè, del suo abuso”, plaudendo da un lato alle ultime scelte della Chiesa e stigmatizzando, dall’altro, quelle della classe politica italiana. “Lo sfondo geopolitico è lo stesso: Roma con il suo Tevere. Al di là del Tevere, in pochi giorni la Chiesa Cattolica è riuscita a trovare la ‘sua’ via della salvezza, affidandosi a un Pastore che già dal suo nome ha saputo dare al suo volto umano, troppo umano, i tratti di una rivincita morale: Francesco. Al di qua del Tevere, invece, si stanno consumando guerre cruente e vergognose, in barba ai più elementari diritti della democrazia stessa – quella vera – e della dignità dell’uomo, del cittadino, specie se appartenente alle fasce più umili e meno disponibili, ormai, a tollerare i giochi di una politica sbagliata”.
Il Rettore dell’ateneo ennese non ha risparmiato considerazioni al vetriolo “sul tema del Potere, del suo uso e, ahimè, del suo abuso”, plaudendo da un lato alle ultime scelte della Chiesa e stigmatizzando, dall’altro, quelle della classe politica italiana. “Lo sfondo geopolitico è lo stesso: Roma con il suo Tevere. Al di là del Tevere, in pochi giorni la Chiesa Cattolica è riuscita a trovare la ‘sua’ via della salvezza, affidandosi a un Pastore che già dal suo nome ha saputo dare al suo volto umano, troppo umano, i tratti di una rivincita morale: Francesco. Al di qua del Tevere, invece, si stanno consumando guerre cruente e vergognose, in barba ai più elementari diritti della democrazia stessa – quella vera – e della dignità dell’uomo, del cittadino, specie se appartenente alle fasce più umili e meno disponibili, ormai, a tollerare i giochi di una politica sbagliata”.
All’interno di questo quadro a dir poco nefasto Puglisi non ha mancato tuttavia di sottolineare alcuni incoraggianti segnali di speranza: “Ho il dovere morale di riconoscere che per taluni versi questa Università che mi onoro di guidare da due anni fa eccezione: lo spirito di partecipazione e la forte e determinata volontà nel ‘volercela fare ad ogni costo’ in una gara in parte oggi impari, in parte entusiasmante con gli altri prestigiosi Atenei siciliani, sono un carburante eccezionale per un motore ancora in rodaggio”.
Si iscrive in questa logica l’iniziativa “Per il futuro, facciamo a metà” della “Kore” di Enna, celebrata simbolicamente alla fine della cerimonia di stamani con la consegna ad alcuni degli studenti, in rappresentanza di tutti gli altri, dell’assegno con cui si restituisce ai “capaci e meritevoli”, e con determinate condizioni di reddito, una parte delle loro tasse di iscrizione.
“Si tratta – ha spiegato Giovanni Puglisi – di 670 dei nostri studenti, appartenenti a tutte le Facoltà, per un impegno economico di 436.000 euro. Ci auguriamo che la responsabilità civile e la lungimiranza politica verranno apprezzate e riconosciute, oltre il valore economico dell’erogazione, così come la nostra proterva volontà di aiutare i giovani e la nostra fiducia morale nella parte migliore del Paese”.

La relazione integrale del Rettore della Kore Giovanni Puglisi
Con tutta sincerità non capita spesso – per non dire che capita forse una sola volta nella vita! – che l’inaugurazione di un anno accademico si collochi in un periodo storico così importante e delicato: ovvero tra l’elezione di un Papa, l’insediamento di una nuova legislatura del Parlamento Repubblicano Italiano, l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e tutto ciò all’interno di una situazione generale, sociale, politica e culturale dell’Italia così difficile e così intricata. Guardare, dunque, fuori dalla nostra finestra e domandarsi cosa accade oltre il nostro sguardo è inevitabile: lo è come cittadini e cittadine del nostro Paese, lo è come educatori e educatrici, lo è come uomini e donne di scienza e di cultura.
La risposta, prima di rintanarsi di nuovo nella nostra turris, di sicuro non più eburnea, è scoraggiante e da far tremare le vene ai polsi: “c’è del marcio in Danimarca” (Amleto, Marcello a Orazio: atto I, scena IV) avrebbe detto Shakespeare; oggi è davvero tutto marcio, aggiungo io! Ciò che rende l’aria esterna mefitica è quel venticello del potere, che fisiologicamente è portatore di ossigeno democratico, ma che nella patologia della vita dei nostri giorni è diventato portatore di corruzione e di sfiducia quasi esistenziale.
Non compete, ovviamente, a me né fare un’analisi della situazione politica italiana e internazionale – il male va infatti oltre i nostri confini – né individuare ricette e men che mai fare sermoni: non è però possibile, in questo momento storico, tirarsi fuori da alcune considerazioni, rapide, ma essenziali, sul tema del Potere, del suo uso e, ahimè!, del suo abuso. Non voglio fare un trattato, ma neppure una breve dissertazione, invero del tutto estranea allo spirito e alla logica della nostra giornata di festa accademica: mi limiterò dunque ad un parallelo storico-politico.
Lo sfondo geopolitico è lo stesso: Roma con il suo Tevere. Al di là del Tevere, in pochi giorni, settimane se mettiamo nel calcolo anche le ultime ore di Pontificato attivo di Papa Ratzinger, la Chiesa Cattolica è riuscita a trovare la “sua” via della salvezza, imboccando la strada, stretta e impervia, della semplicità e dell’umiltà. Una rifondazione “originaria” che tenta di far dimenticare la sopraffazione – ormai quotidiana nei Palazzi Vaticani – del “piacere del potere” sul “piacere dell’etica”. Al di qua del Tevere, invece, sotto l’ipocrisia dell’ombrello democratico, si stanno consumando guerre, soprattutto intestine, cruente e vergognose, in barba ai più elementari diritti della democrazia stessa – quella vera – e della dignità dell’uomo, del cittadino, specie se appartenente alle fasce più umili e meno disponibili, ormai, a tollerare i giochi di una politica sbagliata, perché sicuramente inefficace, classista, e spesso anche corrotta. Anche qui il potere è diventato fine a se stesso. È poi aberrante vedere, per converso, sul podio della moralità ergersi l’icona di un giustizialismo demagogico, vestito dei panni della intransigenza acritica, pronto a sfasciare tutto per arrivare – è qui il punto – al potere senza condizioni e senza controlli, tranne, ancora una volta, quelli autoreferenziali, della cui facies il nostro Paese, poco meno di un secolo fa, ha avuto un vergognoso esempio, con l’avvento del fascismo.
Ecco le due facce del Potere che si fronteggiano sulle due sponde del Tevere: la prima, espressione di un potere vero e solido dei suoi due millenni di vita, che coglie la profondità e la gravità della crisi e sa risorgere dalle ceneri di un contagio nefasto di origine secolare degli ultimi anni, affidandosi ad un Pastore, che già dal nome ha saputo dare al suo volto, umano, troppo umano, i tratti di una rivincita morale: Francesco. E ci piace collegare la scelta a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, simbolo di rigore e umiltà.
Era accaduto già un’altra volta: infatti, secondo Dante il San Francesco dell’Undicesimo Canto del Paradiso ottocento anni fa fu la cellula rigeneratrice della Chiesa romana, anche quella volta dilaniata dalle lotte di potere: “Questa [la Povertà], privata del primo marito, millecent’anni e più dispetta e scura fino a costui [ Francesco] si stette sanza invito;
…
Ma perch’io non proceda troppo chiuso, Francesco e Povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso.
La lor concordia e i lor sembianti, amore e meraviglia e dolce sguardo facíeno esser cagion di pensier santi.” ( Par. XI vv. 64-66; 73-78)
Francesco ricompare oggi, ottocento anni dopo, attraverso l’immagine di un Papa argentino, figlio di immigrati piemontesi, di sottile ingegno gesuita, che ritorna nella sua terra con la sola ricchezza della sua fede e l’irresistibile fascino della sua parola, pacata e suadente. La seconda faccia del potere, quella al di qua del Tevere, ha le sembianze di una maschera teatrale urlante e minacciosa, che evoca odio e vendetta, “arrendetevi”, in un Paese che di tutto ha bisogno, tranne che di odio e di vendette.
Proprio per antitesi a questa insipida incultura della politica italiana, mi permetterete di rivolgere un grato e commosso pensiero a Benedetto XVI, Papa Ratzinger, Pastore amabile, Teologo e Filosofo rigoroso, Intellettuale curioso ma rispettoso, Uomo gentile e raffinato, Persona intransigente seppur fragile, uscito di scena con una garbo personale e istituzionale impareggiabile. La Sua scelta di “nascondersi al mondo” è per un verso il più grande atto d’amore che Egli potesse concepire per testimoniare il suo amore verso Dio e verso la “sua” Chiesa fin allora vociante e quasi indomabile, ma insieme, per un altro verso, è il recupero dell’autenticità più profonda della solitudine, che avvolge – come del resto ha sempre avvolto – la sua Persona e il suo destino di Uomo di Dio. La temporalità del suo “esserci” nel mondo, nella mondanità dissipata, direbbe il suo connazionale, Martin Heidegger, riscopre l’autenticità e la pienezza dell’Essere nella profondità del silenzio, che nascosto al mondo, ritrova l’epifania della Verità rivelata. Grande Personaggio, che lungi dallo “scendere dalla Croce” l’ha sussunta integralmente nella virtualità sacrale dell’esperienza mistica, evitandone la banalizzazione mediatica, in piena coerenza con la sua “filosofia” di vita.
Mi inchino oggi a Lui, con il rispetto e – se mi è consentito – con l’affetto che si deve al Padre, che vive in noi proprio perché vuole essere cercato e scoperto ogni giorno, ogni ora della nostra vita. Benedetto XVI ha detto, congedandosi dal Presidente Napolitano, che pregherà per l’Italia: noi pregheremo il Padre per lui, perché ce lo conservi a lungo, anche se invisibile al mondo. Il nuovo Papa sembra davvero all’altezza del difficilissimo compito che Benedetto XVI gli ha affidato con chiarezza, anche se con evangelica semplicità. E se davvero ci fosse una regia, anch’essa invisibile, dello Spirito Santo!?
Mi permetterete ancora se quest’anno la mia “relazione” sarà – come forse s’è già visto dal suo incipit – un po’ come un “fuori onda”: la prassi accademica, l’abitudine retorica, il galateo istituzionale vogliono che la Relazione del Rettore all’inaugurazione dell’anno accademico sia un po’ il punto sullo stato dell’Ateneo e – al massimo – sulla condizione universitaria del nostro Paese. Quest’anno io vorrei piuttosto raccontarvi una storia, la storia di un accademico che alle soglie del quarantacinquesimo anno di vita universitaria si ritrova disorientato e solo in una giungla, più simile alla monade leibniziana, senza porte e senza finestre, che a un nomade, disperso dantescamente in una “selva oscura selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura”. L’immagine è scelta accuratamente: la selva dantesca – come tutta la Commedia – è popolata di mostri e di angeli, di diavoli e di santi, di malfattori e di ignavi, di peccatori e di asceti, teologicamente divisi per gironi e cieli, ma tutti organizzati in funzione della Luce assente o presente, vicina o lontana.
La monade, alla quale io penso, va oltre quella di leibniziana memoria, è più vicina alla sua derivazione etimologica – il greco μονάς, l’uno indivisibile – paurosamente isolata, cieca e muta o ammutolita, senza speranza e senza più disperazione: inarrivabile al bene e al male, al sorriso e al pianto, alla gioia e al dolore. Sorda e muta rispetto ai clamori della vita, ma anche rispetto alle armonie della creazione. Interdetta nell’azione, ma anche impossibilitata a reagire.
Il passaggio dalla prima accezione della selva a quella della monade racchiude la storia dell’Università italiana dell’ultimo mezzo secolo che abbiamo alle nostre spalle, di quei quarantacinque anni, in buona sostanza, che segnano anche la mia storia accademica. Ho difficoltà a rimpiangere il famoso ’68, che ebbi pure a frequentare, da studente contestatore prima e da giovane docente inesorabilmente contestato dopo, ma ho maggiore difficoltà a ritrovarmi in questa Università italiana del Terzo Millennio dove la cifra prevalente è l’atomismo più esasperato, del tutto privo di quella geniale virtù del clinamen epicureo, che permetteva agli atomi, deviando “impercettibilmente la loro traiettoria” – come scrive Lucrezio nella sua splendida opera De rerum natura – insieme alla formazione della materia, la conoscenza. Ho però il dovere morale di riconoscere che per taluni versi questa Università – forse per la sua giovane età, forse per la sua condizione di forte tensione competitiva – fa eccezione: lo spirito di partecipazione e la forte e determinata volontà nel “volercela fare ad ogni costo” in una gara in parte oggi impari, in parte entusiasmante con gli altri prestigiosi Atenei siciliani, sono un carburante eccezionale per un motore ancora in rodaggio.
Nel nostro infelice Paese, invece, in questo mezzo secolo abbiamo assistito alla liquidazione, quasi scientifica, di quella universitas studiorum che aveva costituito agli albori del Secondo Millennio la culla della libertà e la palestra dell’educazione alla ricerca e all’erudizione, come strutture portanti di quel laboratorio unico e irripetibile che fu, soprattutto nel nostro allora frammentato Paese, l’Umanesimo e il Rinascimento: non è un caso che la più antica Universitas studiorum sia la nostra Alma Mater bolognese, che affonda le sue radici nella selettiva cultura medievale. La cultura medievale era di certo selettiva, ma aveva una forte tensione morale all’alfabetizzazione di qualità – da qui le universitas studiorum! – e alla conservazione e valorizzazione dei suoi tesori – da qui la ricchissima raccolta di testi e codici della classicità arrivati fino a noi, passando appunto per una storia culturale tesa alla continuità di queste tradizioni alte e nobili, dall’Umanesimo fino al Romanticismo, passando per il razionalismo cartesiano, il panteismo spinoziano, lo storicismo vichiano e l’illuminismo volterriano.
Per converso ciò che mi preme evidenziare è la singolare e strana convergenza, che “lega” l’itinerario politico-civile della nascita gloriosa delle Università italiane dei secoli scorsi, a quello di questo ultimo scorcio di secolo. La variante è stupefacente: alle origini la vita di ciascuna universitas era al centro delle attenzioni politiche e civiche dei diversi poteri temporali o ecclesiastici che se ne facevano carico [si pensi, per tutte, all’esenzione data agli scolari di fare il “servizio militare” – si direbbe oggi così – nel corso dei loro studi, in epoche nelle quali le genti combattevano spesso per la loro sopravvivenza]; da circa cinquant’anni la vita delle nostre Università è, invece, una storia quasi estranea alla vita politica del Paese, che la vive talora con distrazione, talora addirittura con fastidio. Oggi – cosa ancor più grave, a mio avviso – con assoluta indifferenza: l’Università italiana, statale e non statale in particolare, non sembra più appartenere a questo Paese, preoccupato principalmente di controllarne i conti, piuttosto che di misurarne la capacità e le performances scientifiche e formative.
Ancora più grave è la situazione delle Università siciliane, dove il sistema autonomistico “speciale” ha finito con il diventare da privilegio costituzionale, castigo quotidiano. Le Università in Sicilia sono quasi figlie di nessuno: lo Stato centrale le considera alla stregua delle altre Università italiane, applicando loro regole, codici e indici di valutazione, assolutamente identici a quelli che applica a Milano, a Udine o a Bologna, o ancora ai Politecnici o alle Università di eccellenza tematica. L’oblio della peculiarità economica e sociale di tutto il Meridione d’Italia, ma della nostra Isola in particolare non costituisce né motivo di differenza, né ragione di preoccupazione politica. La Regione Siciliana affogata dalle difficoltà finanziarie e dalle pressioni sociali ed economiche della crisi gravissima che attraversa tutta l’economia isolana, non mi sembra abbia messo le sue Università, statali e non statali, al centro delle proprie attenzioni, né fra le prime priorità della sua agenda legislativa e di Governo. Dimenticando che in queste aule si costruisce la Sicilia del futuro, quella che potrà garantire ai giovani di oggi e di domani la dignità di vivere da cittadini onesti e l’orgoglio della propria identità insulare.
Se la Sicilia ha perso la sfida dell’autonomia, se non ha saputo trasformare la straordinaria opportunità del suo Statuto in sviluppo, se ci troviamo agli ultimissimi posti in Italia sul piano del reddito e dell’occupazione e vantiamo invece meschini primati nel campo della criminalità, della dispersione scolastica, della collusione della classe politica, se oggi inseguiamo populismi e masaniellate, trasformisti e voltagabbana, la colpa non è solo di Roma, dove nessuna di queste categorie invero difetta. Oltre la soglia e l’onestà intellettuale e politica dei Padri dell’Autonomia, pochi invero, la parte maggiore dei sessantacinque anni di autonomia “speciale”, di speciale ha avuto solo l’incapacità a trasformare o a consolidare un’opportunità istituzionale in progetto politico. Il privilegio di un’autonomia speciale, ovvero federale, sacrificato sull’altare di una crescente subalternità della classe politica insulare al potere romano, ha consegnato la Sicilia al suo più triste primato, facendo del privilegio un castigo: non c’è, infatti, regione al mondo in cui la mafia ha decapitato tutte – dico tutte – le istituzioni da Piersanti Mattarella a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Rocco Chinnici a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, da Pio La Torre a Ninni Cassarà, da Pietro Scaglione a Rosario Livatino, a Mario D’Aleo, a Emanuele Basile, ma anche significativi esponenti della società civile come Mauro De Mauro, Peppino Impastato, Paolo Giaccone, don Pino Puglisi, tutti i ragazzi delle scorte, l’anima candida e disperata di Rita Atria e tanti altri ancora, la cui individuale citazione sarebbe tanto afflittiva, quanto deprimente.
Che angoscia per questi Caduti, che vergogna per le perdute occasioni di valorizzazione della dignità autonomistica, che forse avrebbero risparmiato molte di quelle vite!
Alla singolare distrazione con la quale il sistema politico italiano ha permesso, anche qui in Sicilia, specie negli ultimi trent’anni – cito per tutti i casi di Caltanissetta [che speriamo di recuperare ad una sinergia positiva nell’alveo dell’Università della Sicilia centrale] a Ragusa, Siracusa, Noto e così via – la moltiplicazione irrazionale e irragionevole delle Università, dei suoi Corsi di studio, delle sue sedi, centrali e periferiche, pronto clientelarmente a riconoscerle subito dopo, ha fatto séguito una altrettanto irragionevole e meramente punitiva azione di strangolamento delle capacità e delle intelligenze disponibili negli Atenei al servizio della ricerca, dissipando risorse accumulate negli anni nella formazione di giovani eccellenti, a favore, spesso, di altri Paesi, pronti a raccogliere il meglio dei nostri giovani, accrescendo così le loro performances e le loro fortune, anche nelle graduatorie dei rankings internazionali, a danno dei nostri Atenei, che invece risultano sempre penalizzanti.
L’ho detto più volte e non voglio qui ripetermi oggi, anche se una rapida “confessione” è doveroso farla, per non essere accusati di ipocrisia. L’uso improprio dell’autonomia universitaria dalla cosiddetta Legge Amato in poi è in buona parte all’origine dei nostri guai, anche se la classe politica che – attenzione: a trecento sessanta gradi! – s’è alternata alla guida del Paese non ha mai né saputo, né, soprattutto, voluto esercitare quella funzione di indirizzo e di verifica, che le leggi in vigore, in via di principio, avrebbero invece sempre permesso al Governo, rispondendo alla logica clientelare, che ha comunque in vario modo orientato gli interventi dei diversi membri dei Governi, che si sono succeduti. Pilatescamente e spesso con malcelata complicità, infatti, hanno dato corda lunga ad un’accademia certamente ingorda, dimenticando adesso le proprie colpe, anzi assurgendo oggi i politici, ipocritamente, a severi giudici degli altrui comportamenti.
Non voglio tediarvi oltre con queste mie considerazioni, desidero solo riportare questa nota istituzionale al mio vissuto personale: l’Università che ho conosciuto e vissuto in questi quarantacinque anni oggi non la riconosco più. Ho avuto la fortuna di essere chiamato, dalla fiducia e dalla stima dei miei Colleghi, ad assolvere compiti di Governo accademico molto giovane e molti anni fa: in quegli anni ho vissuto e conosciuto l’Università dei Maestri e delle Scuole, quella in cui il merito – qualunque cosa si voglia, con piglio iconoclasta, dire oggi – alla fine era sempre sovrano. I Maestri sapevano scegliere, con assoluta discrezionalità, ma con altrettanta sicurezza scientifica: le abilitazioni, le idoneità erano sempre propedeutiche a valutazioni vere e proprie e gli ope legis, anche camuffati, erano una bestemmia. L’entropia del sistema, nel quale idoneità, ope legis più o meno mascherati e adesso abilitazioni di massa sono di casa e di norma, ha generato mostri, moltissimi mostri. Per carità, anche un secolo fa esistevano i mostri accademici, ma erano un’esigua minoranza, oggi forse le proporzioni sono capovolte! Mi viene in mente la splendida metafora dantesca del XII canto del Paradiso, quando il Grande Fiorentino mette in bocca al francescano San Bonaventura di Bagnoregio un tagliente giudizio sui seguaci di San Tommaso: “La sua famiglia, che si mosse dritta coi piedi a le sue orme, è tanto volta, che quel dinanzi a quel di retro gitta” (vv.115-117)
L’Università italiana di oggi sembra fare il cammino opposto a quella prestigiosa dei secoli scorsi, mettendo le punta dei piedi dove quella del suo glorioso passato metteva le calcagna. È tutta colpa degli accademici? Certamente no.
L’Università è figlia e specchio del proprio tempo, ieri come oggi, nel Medioevo come ai nostri giorni, e questo è un tempo in cui la cultura, l’istruzione, la ricerca hanno perduto il gusto della verità, che equivale a dire che hanno perduto il diritto di cittadinanza attiva: la verità dovrebbe essere quella di affermare se stessa, per affermare – senza se e senza ma, come si ama dire adesso – il diritto alla propria sopravvivenza e alla propria libertà e, quindi, alla loro libera espressione.
Il fascismo privò l’Università della sua libertà d’insegnamento, mettendo il bavaglio a centinaia di studiosi e di docenti [solo 13 docenti su più di un migliaio rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista, scrivendo una pagina di orgoglio per un verso e di ignominia per l’altro, della nostra storia accademica], il post-fascismo dei nostri giorni sta privando l’Università, la scuola, la ricerca, in una parola la cultura, del diritto di sopravvivenza, affidandola ad una eutanasia guidata – come saggiamente ha denunciato la Conferenza dei Rettori – tragicamente irreversibile.
Privare l’Università del suo diritto di esistere vuol dire innanzi tutto privare la società della più autentica e più nobile scuola di diritto e di libertà: una società immorale e illiberale sarà – o forse è già? – la conseguenza più naturale e irreversibile. Il piacere dell’etica e il gusto delle regole sono il sale di una società civile degna di questo nome, dove il rispetto della persona, come quello della natura, degli animali, di ogni forma di esistenza sia garantita. L’identità si rispetta attraverso il culto della diversità, anzi delle diversità: lo ha sancito l’UNESCO, lo ha ratificato il nostro Parlamento. Lo ha affermato da ultimo, in questi giorni anche Papa Francesco, quando ha difeso, come valore, “l’unità delle differenze nell’Armonia”. È ora di fare diventare tutto ciò davvero “patrimonio dell’Umanità”, ovvero di tutti noi, anche in Italia.
L’Università di Salamanca ha una singolare e originale abitudine, quella di piantare nel suo giardino un albero per ogni suo Dottore Honoris Causa: a chi parla, al quale ha conferito una Laurea honoris causa in Filologia, ha dedicato un Taxus baccata: albero resistente, che si distingue per le sue proprietà farmacologiche, producendo una sostanza, la tassina, che può essere usata come principio attivo di prodotti chemioterapici per la lotta ad alcune forme di cancro, in particolare utilizzata in alcune forme neoplastiche a livello ovarico. Non conosco le ragioni della scelta, che probabilmente è assolutamente casuale: debbo però ammettere che mi riconosco in questa icona. È l’icona della determinazione alla positività, volta anche a salvare l’irreparabile. La versione negativa di questa dedica è paradossalmente il nome volgare che assume il Taxus baccata, ovvero albero della morte. Confesso che questa ambiguità linguistica non mi ha turbato per nulla: la vita e la morte sono, infatti, due facce di una stessa medaglia, che non riescono mai a guardarsi in faccia, come la bontà e la malvagità, il bello e il brutto, il morale e l’immorale, il colto e l’incolto, il diritto e il delitto. La loro declinazione non è ontologicamente prescritta, ma si esprime “debolmente” secondo il soggetto, la situazione, le condizioni che determinano quelli che Baruch Spinoza chiamava i “modi”. Spinozianamente la “Sostanza è una realtà oggettiva indipendente dalla esistenza” che la esprime, i ”modi invece sono i singoli corpi (modificazioni accidentali dell’estensione), e le singole idee (modificazioni del pensiero). Viviamo in un mondo e in particolare in un momento nel quale i modi hanno finito con il prevalere sulla Sostanza.
La malvagità, il brutto, l’immoralità, l’incultura e spesso l’ignoranza, il delitto sono riusciti a prevalere sull’Autenticità dell’Uomo. Attenzione ciò che rischia di prevalere oggi non è solo l’episodicità dell’eccezione delittuosa, ma l’esemplarità capovolta di una diffusa tolleranza alla normalità dell’immoralità.
Orribile! Abbassandosi la soglia dell’eccezione, questa diventa la regola, ma per converso – ed è la cosa ancora più grave – la regola non diventa l’eccezione, ma scompare del tutto. L’uso e l’abitudine prevalgono sulla norma, l’espediente sulla regola. Qualche anno fa da questa Cattedra invocavo e auspicavo il ritorno ad una civiltà nella quale l’etica fosse non un imperativo categorico di kantiana memoria, parlavo addirittura del piacere dell’etica: oggi debbo riconoscere che siamo lontani da un mondo eticamente soddisfatto. Anzi parlerei di esilio dell’etica. L’università in questa stagione ha responsabilità enormi, ma anche ancora potenzialità enormi.
Le prime sono sotto gli occhi di tutti: le difficoltà di dialogo civile e politico del sistema universitario con il sistema-Paese sono la ragione principale della crisi del sistema dell’alta formazione. Io non so se il tempo che abbiamo davanti ci permetterà di recuperare questa relazione in modo virtuoso, risalire la china di questa deriva reale e mediatica sarà molto difficile per tutti, universitari, politici, industriali, imprenditori, giornalisti, opinion makers. È però l’unica forma di recupero di quella centralità dell’educazione, intesa in senso anglosassone, che sta alla base di ogni società civile degna di questo nome. L’educazione – proprio come ci insegna la bellissima metafora botanica dell’Università di Salamanca – è una pianta, che dopo il suo impianto germoglia e cresce in ragione della sua aspettativa di vita, ma anche in ragione dell’ambiente nel quale vive: il giardino dei Dottori Honoris causa di quell’Ateneo storico è più che un messaggio accademico, è un messaggio di vita, e soprattutto un messaggio politico. Dall’Università, come da ogni missione esistenziale, non si esce più, la sua vocazione culturale è anche la sua identità esistenziale, proprio come l’identità biologica di un albero. L’Università può essere uccisa per suicidio o per eutanasia. Il primo è contro natura, la seconda è quella che il sistema politico italiano sta praticando alla nostra povera Università. Ribelliamoci con l’orgoglio della nostra storia, con la forza delle nostre idee e con la dignità della nostra moralità. Basta espellere le mele marce e tenere alta la soglia della moralità, fino all’asticella del suo piacere ontologico. È possibile, ve lo assicuro, basta coraggio e fiducia. Così, e solo così, forse riusciremo a diventare di nuovo magistra vitae, in un tempo e in una società che ha abbassato tutte le asticelle fino a perderne anche la traccia simbolica. Le recenti consultazioni elettorali hanno dato la rappresentazione di una democrazia sofferente, la quale ha perduto il legame essenziale tra rappresentanza e rappresentatività. La metà degli Italiani ha, in modo articolato, mandato un segnale inequivocabile all’altra metà: non siete più rappresentativi del Paese reale. Cogliere il messaggio è più importante che baloccarsi sulle formule di Governo. E cogliere il messaggio vuol dire partire dalla scuola, dall’Università e dalla cultura: innanzi tutto con gli esempi e le azioni, le parole non bastano più, le promesse non servono più, soprattutto all’Italia. Faccio appello in particolare ai giovani, tanti, donne e uomini, che stanno per entrare nel nuovo Parlamento della Repubblica: abbiano un sussulto di dignità, pensino e guardino ai loro coetanei, a coloro che in gran parte sono fra i principali contributori del tasso di disoccupazione o di inoccupazione intellettuale e materiale e impongano ad un sistema politico ormai decotto e impresentabile in gran parte, oltre gli schieramenti, una politica della formazione di qualità, che ancorata a monte alla scuola e all’Università, e a valle ad un sistema produttivo sano e moralmente sostenuto, possa invertire il flusso della disperazione. Guardo con orrore all’Italia dei prossimi trenta o quaranta anni, un’Italia nella quale ad invecchiare saranno i giovani di oggi, quelli inoccupati o disoccupati, che attendono un lavoro per versare i loro contributi assicurativi per la pensione, i quali diventeranno anziani in un Paese paurosamente povero, privo di mezzi per vivere e farli sopravvivere. Ancora una volta mi vengono alla mente tre famosi versi danteschi, tratti dal VI canto, questa volta, del Purgatorio: “Ai serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello” (vv 76-78).
Da quei versi sono passati più di settecento anni, durante i quali l’Italia non solo ha retto, ma è diventata una e indivisibile e ha retto a sciagure, disastri e dittature, oggi, invece, temo che corriamo il rischio serio che l’attualità dantesca superi ogni forma di previsione politica!
Potrei, a questo punto, riprendere il filo logico di una Relazione tradizionale, ma sono agevolato dal mio Amico Cataldo Salerno, che ha svolto con magistrale esperienza la sua Relazione di Presidente, come con la stessa magistrale esperienza e dedizione guida la struttura di questa Università, affiancato da tutti gli Organi di Governo e in particolare dall’eccellente Direttore Generale, Salvatore Berrittella, il tutto sempre sotto l’occhio vigile e attento della Fondazione Kore.
Voglio solo darVi una testimonianza di impegno, a tutto campo e senza risparmio, di tutti, dico di tutti coloro che, insieme a me, condividono la guida accademica e scientifico-didattica, strategica e quotidiana di questo Ateneo: abbiamo fatto passi avanti enormi nell’impegno e nei risultati didattici e scientifici, ma, mi sia consentito testimoniarlo, anche amministrativi e strutturali. Essi sono sotto i Vostri occhi, a partire dalla rimodulazione delle Facoltà dell’Ateneo, orientata alla razionalizzazione dell’offerta, ma anche alla visione di rendere la nostra Università sempre più funzionale ad un progetto territoriale di integrazione e utilità sociale.
Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti gli Amministratori e i Presidi della comprensione, soprattutto in un momento molto delicato della vita economica e sociale del Paese e anche del nostro Ateneo: voglio ancora soltanto sottolineare che la nostra è una Università non statale, la cui funzione pubblica è a noi di certo ben nota, anche se negletta e misconosciuta dal Parlamento e dal Governo del nostro Paese. Noi ce ne facciamo carico morale adottando tutte le misure, strutturali e anche economico-finanziarie, che possiamo, senza avviarci verso il suicidio guidato!, per garantire i livelli economici dell’Ateneo in linea con l’offerta degli Atenei statali e con le condizioni socio-economiche della nostra Regione e delle nostre famiglie siciliane. Ciò è possibile farlo grazie alla saggia e oculata amministrazione di questa Università, che ha saputo fare dei suoi pur bervi anni di vita una fortunata occasione di sviluppo territoriale, un’opportuna civile e morale per tutta la nostra gente, i nostri giovani, le loro famiglie. Si iscrive in questa logica l’iniziativa “Per il futuro, facciamo a metà” che celebreremo simbolicamente alla fine di questa cerimonia, con la consegna ad alcuni dei nostri studenti, in rappresentanza di tutti gli altri, dell’assegno con cui restituiamo ai “capaci e meritevoli” e con determinate condizioni di reddito, una parete delle loro tasse di iscrizione. Si tratta di 670 dei nostri studenti, appartenenti a tutte le Facoltà per un impegno economico di 436.000,00 euro.
Ci auguriamo che la responsabilità civile e la lungimiranza politica verranno apprezzate e riconosciute, oltre il valore economico dell’erogazione – che per altro, essendo di quasi mezzo milione di euro, non mi pare che sia cosa da poco! – apprezzate e riconoaciute come la nostra proterva volontà di aiutare i giovani e la nostra fiducia morale nella parte migliore del nostro Paese, credo, meritano. In verità la nostra Costituzione all’art. 34 afferma: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”: ci siamo voluti allineare con la Carta costituzionale come messaggio politico di adesione morale ad un principio costituzionale, che davvero in questo momento diventa la cartina di tornasole di uno spirito unitario del nostro Paese: declinare le differenze, per affermare l’unità! È questo il mio secondo anno di Rettorato in questa bella e giovane Università: non voglio assolutamente ripetere quanto ho più volte detto, e cioè il mio desiderio di contenerne al massimo la durata. Ripeterlo sarebbe ridondante, farlo hic et nunc sarebbe fedifrago e codardo. Resta il fatto che il problema per me si pone: per un professore universitario quarantaquattro anni di vita accademica sono molti, anzi moltissimi, ne sento tutto il peso, anche se ne porto l’orgoglio. Più gravoso ancora è il carico rettorale, che mi vede diviso tra due realtà, geograficamente così lontane, ma così vicine entrambe, ormai, nel mio cuore. Confesso che mi cominciano a pesare, oltre che ad annoiarmi per la loro stucchevole ripetitività, gli occhi dell’invidia, che dantescamente ritengo infamante e mortale solo per chi la prova: “La meretrice che mai da l’ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e de le corti vizio” (Inf. XIII vv. 64-66) Vado in ogni caso avanti, con impegno, rigore e umiltà, nel fare il mio servizio, ritenendo per il momento che il mio dovere sia quello di continuare a lavorare con Voi e per Voi, il tempo ancora necessario, per consegnare a tutti, soprattutto ai Colleghi più giovani, ai giovani studiosi che si sono avvicinati in questi anni, in questa Università all’amore per la scienza, la ricerca e la verità scientifica, un’Università non solo bella nell’aspetto, ma soprattutto ricca nelle intelligenze e attraversata dal quel piacere dell’etica, che a me sta tanto a cuore.
Con questi sentimenti e con questi voti augurali, con l’aiuto di Dio, dichiaro aperto l’Anno Accademico 2012-2013, VIII dalla Fondazione, della Libera Università Kore di Enna.
Viva l’Italia, la nostra grande e bella Italia, una e indivisibile!