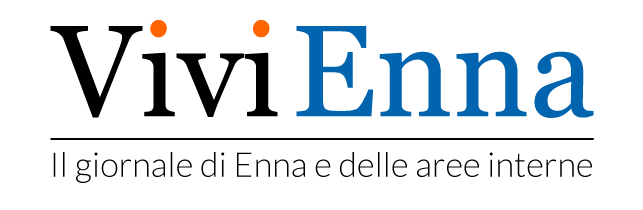La Caritas in Veritate dai circoli MCL all’Università di Palermo
Enna-Cronaca - 03/11/2009
Palermo. E’ stato l’arcivescovo metropolita Mons.Salvatore Romeo, presidente della CESi, ad aprire, dopo il saluto della facoltà di Economia, nella città universitaria di Palermo, il convegno sulla Enciclica sociale di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, organizzato dagli uffici diocesani della cultura, della pastorale sociale del lavoro, giustizia e pace, dell’educazione,della scuola cattolica e dell’università.
Le Encicliche di Benedetto XVI che precedono la crisi attuale, per il Presule, hanno rivendicato un riequilibrio nel rapporto dell’economia con l’uomo. L’economia dell’indifferenza, in nome dell’efficienza, è un’economia senza anima, senza spirito cristiano ed è all’origine della crisi. L’insegnamento del pontefice propone un’etica per l’economia, che deve rendere un servizio alla persona, un servizio d’amore nella verità.
Ed è la carità per il preside della Facoltà teologica della Sicilia Prof.Rino La Delfa, che ha presentato gli aspetti teologici dell’Enciclica ,a dare vera sostanza al rapporto personale dell’uomo con Dio. La verità può essere sperimentata con il dono, con la gratuità, con l’amore, nel segno dell’unione dell’uomo con gli altri, nel favorire una cultura di relazionalità, di comunione, di condivisione.
Al convegno hanno portato il contributo d’analisi e d’approfondimento dei molti temi della Lettera Enciclica, i Professori Leonardo Becchetti dell’Università Tor Vergata di Roma, (l’Enciclica richiede nuovi attori, modelli diversi d’impresa, nuove virtù quali la fraternità ), Francesco Viola dell’università di Palermo, (la giustizia non si può realizzare senza la carità,che è il fine della politica e la questione sociale e politica è diventata antropologica , legata allo sviluppo integrale dell’uomo ). Il prof.Giuseppe Notarstefano della facoltà d’Economia ha coordinato il dibattito, che ha avuto ampi richiami al dialogo interreligioso con gli islamici e con chiese evangeliche.
Al palazzo Steri, sede del rettorato dell’Università di Palermo si annuncia, intanto, nel quadro delle Giornate dell’economia del Mezzogiorno dela Fondazione Curella un altro convegno in merito alle indicazioni economiche dell’Enciclica.
E la Chiesa, nella sua dimensione universale, si appalesa, nell’Enciclica,in tutta la sua vocazione e stravolge il rapporto uomo-mercato, all’insegna della solidarietà e della dignità dell’uomo. (1)
“Poiché dono ricevuto da tutti, ”la carità nella verità” è una forza che costituisce la comunità,unifica gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini…La logica del dono non esclude la giustizia…lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno,se vuole essere autenticamente umano,di fare spazio al principio di gratuità come espressone di fraternità”.
L’affondo con i mercati, di cui si è fatto portavoce Mons.Romeo, è evidente e si trasferisce nelle riflessioni degli studiosi, nelle Università, quando l’eco dell’enciclica raggiunge i circoli del Movimento Cristiano dei Lavoratori e l’associazionismo laicale. Nelle sue valenze positive permette l’incontro tra le persone che utilizzano “il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri”, secondo quella che è la giustizia commutativa. Ma “ senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica”.
Ci sono energie morali da trarre da altri soggetti, senza le quali il mercato non realizza una vera emancipazione, non assume una funzione ed un ruolo nei riguardi di tutta l’umanità. In altri termini, “l’attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della legge mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica”.
L’Enciclica rilancia il valore e la continuità della dottrina sociale della Chiesa. Questa “ha sempre sostenuto che la giustizia riguarda tutte le fasi dell’attività economica, perché ha sempre a che fare con l’uomo e con le sue esigenze. Il reperimento delle risorse, i finanziamenti, la produzione, il consumo e tutte le altre fasi del ciclo economico hanno ineluttabilmente implicazioni morali”.
E l’etica la fa da padrone, i canoni della giustizia pervadono tutte le fasi dell’economia.Nel mercato si aprono spazi per attività economiche realizzate da soggetti che liberamente scelgono di informare il proprio agire a principi diversi da quello del puro profitto, senza per ciò stesso rinunciare a produrre valore economico. “Le tante espressioni d’economia che traggono origine da iniziative religiose e laicali dimostrano che ciò è concretamente possibile”.
Si riapre e si esalta il fronte sperimentale e già degno di significato delle tante iniziative socio-economiche, che il volontariato ha promosso in questi anni, che la generosità ha esaltato per il valore del dono senza contropartita nell’offerta delle attività economiche, specie nei servizi, sempre più liberalizzate dall’affanno del profitto del” costi quel che costi”.
Il lavoro e l’impegno, talvolta rischioso, della sperimentazione di offrire servizi senza fini di profitto, che ha caratterizzato l’impegno della cooperazione, delle banche di credito cooperativo, delle Banche etiche, delle Opere culturali e sociali del vasto mondo del volontariato del terziario,
dei movimenti operai, trovano l’alto riconoscimento nell’Enciclica, sulla scia della Centesimus annus “che aveva rilevato la necessità di un sistema a tre soggetti: il mercato,lo Stato e la società civile”.
Ed è che quest’ultima è cresciuta, in tutte le realtà, specie quando le crisi, le mobilità, le città metropolitane, i poveri del mondo, gli immigrati, hanno visto come essenziale la partecipazione solidale e fraterna dell’associazionismo e delle imprese non profit, nel prestare i servizi primari ed essenziali al prossimo.
“La solidarietà”, afferma l’Enciclica, “è anzitutto sentirsi tutti responsabili di tutti, quindi non può essere delegata solo allo Stato”…” Accanto all’impresa privata orientata al profitto e ai vari tipi d’impresa pubblica devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive, che perseguono fini mutualistici e sociali”.
Il via è dato a quel che l’Enciclica chiama la “civilizzazione dell’economia”. “Carità nella verità, in questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fino a se stesso”.
Si riaprono e si amplificano gli spazi dell’associazionismo solidale, quello che ha visto le ACLI, il MCL, la Cooperazione, le unioni categoriali e professionali, il sindacato, crescere e rispondere a certi bisogni del nostro tempo, improvvisi e, a volte, decisivi per la serena vita di molte famiglie e d’interi popoli.
E la crisi che attraversa globalmente l’universo ai nostri giorni non è da meno. Le dinamiche della globalizzazione portano al superamento ed all’insufficienza del solo apporto distributivo dello Stato.
Ricorda l’Enciclica: “La globalizzazione va senz’altro intesa come un processo socio-economico, ma questa non è l’unica sua dimensione. Sotto il processo più visibile c’è la realtà di un’umanità che diviene sempre più interconnessa; essa è costituita da persone e da popoli a cui quel processo deve essere d’utilità e di sviluppo, grazie all’assunzione da parte tanto dei singoli quanto della collettività delle rispettive responsabilità. Il superamento dei confini non è solo un fatto materiale, ma anche culturale nelle sue cause e nei suoi effetti”.
Ed ancora, “La verità della globalizzazione come processo e il suo criterio etico fondamentale sono dati dell’unità della famiglia umana e del suo sviluppo nel bene”.
All’apparenza sembra tutto scontato, ma se riflettiamo sulle relazioni con l’associazionismo laicale nel quale in molti siamo impegnati, allora ci risuona sul piano progettuale, congressuale, operativo, quanto ancora Benedetto XVI ci suggerisce: “Occorre quindi impegnarsi incessantemente per favorire un orientamento culturale personalista e comunitario, aperto alla trascendenza del processo d’integrazione planetaria”.
I movimenti ecclesiali avvertano il cambiamento in atto e ritrovino nei comportamenti, programmi, azioni, servizi, quella dimensione nuova che si richiede alla missionarietà della Chiesa, alla quale apparteniamo, per consentire “di vivere ed orientare la globalizzazione dell’umanità in termini di relazionalità, di comunione e di condivisione”.
Se pensiamo solo ai servizi formativi, a quelli dell’accoglienza, a quelli dell’integrazione e del dialogo tra le differenti culture, da realizzare intanto nelle nostre città con gli immigrati crescenti di numero e di famiglie, constatiamo come il rinnovamento progettuale dei movimenti dovrà intervenire sul piano dei programmi interni e su quelli con il mondo con cui saremo sempre più in comunicazione.
“La solidarietà universale”, ci ricorda ancora l’Enciclica, “è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere”.
Non basta, infatti, la difesa dei diritti, attorno ai quali sono nati alcuni servizi di patronato, delle ACLI, del MCL, della CC.DD, dei sindacati ed inizialmente quasi solo per gli iscritti. Nè sarà sufficiente delegare alle organizzazioni internazionali, il compito di diffondere, anche loro, i diritti dell’uomo e dei popoli, senza tenere alto e determinante il ruolo dell’aiuto “ad essere artefici del loro destino, ossia ad assumersi a loro volta dei doveri. La condivisione dei doveri reciproci mobilita assi più della sola rivendicazione dei diritti”.
Né si può vedere in ciò un neocolonialismo dottrinale e ideologico dei popoli ricchi.
“La concezione dei diritti e dei doveri nello sviluppo deve tenere conto anche delle problematiche connesse con la crescita demografica. Si tratta di un aspetto molto importante del vero sviluppo perchè concerne i valori irrinunciabili della vita e della famiglia”.
Non poteva mancare al riguardo un’indicazione agli Stati. Se l’apertura moralmente responsabile alla vita è una ricchezza sociale ed economica, “gli Stati sono chiamati a varare politiche, che promuovano la centralità e l’integrità della famiglia ,fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, prima e vitale cellula della società,facendosi carico anche dei suoi problemi economici e fiscali, nel rispetto della sua natura relazionale”.
Solo così, rispondendo alle esigenze morali più profonde della persona, si potranno prospettare ricadute nella vita economica ed essa si nobilita del suo esenziale valore etico.
E sarà questa dimensione etica ad imporre il rispetto per l’ambiente, per la natura, per la vita: “il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell’ambiente come sul versante della vita, della sessualità,del matrimonio,della famiglia,delle relazioni sociali,in una parola dello sviluppo umano integrale”. (51-Enciclica)
Ferdinando Russo
onnadorusso@libero.it
1) Benedetto XVI, Caritas in Veritate, capitolo IV