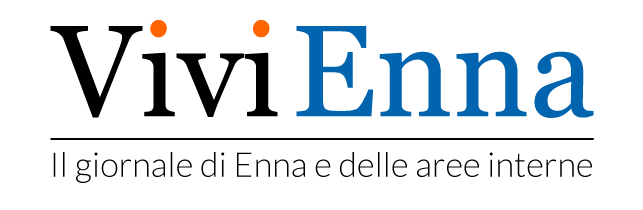Dossier Legambiente Sicilia su zolfare siciliane
Enna-Provincia - 09/04/2010
 Salviamo l’arte mineraria. 25 cose da fare subito per l’archeologia industriale delle zolfare siciliane.
Salviamo l’arte mineraria. 25 cose da fare subito per l’archeologia industriale delle zolfare siciliane.
Se vogliamo davvero invertire la rotta e salvare ciò che resta della civiltà dello zolfo, se vogliamo mettere in campo un’azione coordinata e concreta per cominciare a togliere dal degrado e dall’abbandono, in cui si trova da oltre vent’anni, un’importantissima parte della storia del popolo siciliano, se vogliamo intensificare il recupero di un patrimonio architettonico unico e raro, ora è arrivato il momento. Domani sarà troppo tardi.
Non stanno bene le zolfare siciliane. Quasi tutte sono sempre di più terra di nessuno, luoghi di incuria, dove si può trovare di tutto in numerose discariche abusive e illegali. Poche hanno visto l’interesse della mano pubblica. E per fortuna ci sono stati tanti volontari e appassionati che hanno lavorato per difenderle da chi voleva depredarle perfino della loro anima.
Accanto alla proposta di disegno di legge per istituire finalmente il Parco geominerario delle zolfare siciliane, presentiamo questo dossier che, occupandosi solo dei siti solfiferi che proponiamo come primo nucleo di partenza per la nascita del Parco, propone degli interventi, piccoli e grandi, per contribuire a salvare l’arte mineraria.
Non parliamo delle cose fatte per le zolfare in questi anni, sono purtroppo poche ma significative. Si tratta ora di metterle in rete e farle conoscere. Anche per questo ci battiamo per l’istituzione del Parco.
In alcuni casi, le nostre proposte e richieste completano e sono collegate a interventi già portati a termine o a progetti che si stanno realizzando.
Questo è solo un primo vademecum se si vuole intervenire con urgenza, per salvare il salvabile, per non perdere tutto, definitivamente.
Venticinque cose da fare subito, attivandosi immediatamente, per salvare una parte significativa dell’archeologia industriale delle zolfare siciliane. Alcune sono a costo zero, altre sono vere e proprie emergenze, altre ancora più di prospettiva e che prefigurano già l’idea, l’attività e le finalità del Parco delle zolfare, per rendere fruibile il meraviglioso patrimonio storico, culturale e architettonico che ancora conservano.
Ci vorrà tanto impegno e volontà, ci vorranno risorse economiche, serviranno diversi espropri, bisognerà convincere ancora tanta gente, ma se ci si crede è questa la strada giusta. Noi faremo la nostra parte, come sempre, perché memoria e bellezza sono il futuro di questa nostra isola meravigliosa.
Gianfranco Zanna
responsabile per i Beni culturali di Legambiente Sicilia
Il dossier è stato realizzato con i contributi di Bernardo Agrò, Mario Cassetti, Ivo Cigna, Antonio D’Aquila, Salvatore Di Vita, Alessandro Ferrara, Donatella Gueli, Angelo Lomaglio, Michele Lombardo, Gianfranco Zanna e Mario Zurli.
Le 25 cose da fare subito per l’archeologia industriale delle zolfare siciliane
Miniera Ciavolotta
La miniera ha una storia secolare che si identifica quasi con quelle dell’industria zolfifera siciliana. Conserva ancora il caratteristico aspetto desolato riarso e lunare della zolfara siciliana. Il giacimento scoperto nella provincia di Agrigento nel 1891, a qualche centinaio di metri dagli affioramenti e a circa 20-25 metri di profondità, ha, grosso modo, la forma di una lente.
Il sotterraneo è estremamente articolato e presenta l’eccezionale formazione geologica delle zubbie, mineralizzazioni di rilevante carattere scientifico ed anche spettacolari, che rendono la Ciavolotta una miniera unica al mondo. Le zubbie si presentano come grandi cavità più o meno piene di minerale quasi puro e circondate da una vasta zona mista di zolfo e gesso con tenori elevati. Sono completamente tappezzate di zolfo mammellonare amorfo di colore e trasparenza simili all’ambra.
Se vogliamo valorizzare questo patrimonio rarissimo, cosa possibile, bisogna intervenire per assicurare l’accesso a queste straordinarie cavità, cominciando dal 1. recupero del piano inclinato “Libia”. La sua imboccatura è ubicata al piano di campagna; da qui si erge la struttura dell’argano posto in posizione elevata. Rappresenta una singolarità tecnica molto rara, si tratta, infatti, di una galleria con struttura in roccia di gesso con arco a tutto sesto, con una inclinazione pari a 45°. La sede, anch’essa in muratura, è costituita da una coppia di binari a scartamento ridotto, i quali sono percorsi da vagoni con meccanica di carico e scarico (adibiti al carreggio).
La galleria intercetta i vari livelli nel suo andamento di inclinazione, dove nelle varie intersezioni, il materiale veniva “spillato” da apposito silos in sottosuolo ed inserito nei vagoni per il suo trasporto in superficie. Dalla superficie gli stessi venivano caricati con i rosticci derivati dalle lavorazioni, al fine di ricolmare i vuoti dei cantieri ormai sfruttati.
Il sottosuolo è in buone condizioni di stabilità e pervietà, ma se vogliamo arrivare alle zubbie l’accesso a tali peculiarità è impedito da un tratto di una trentina di metri del piano inclinato che ha ceduto a circa cento metri dall’imbocco ed è quasi ostruito. Superato questo dissesto statico 2. l’intera miniera è facilmente ripristinabile, almeno sino al ventisettesimo livello, con l’accesso assicurato alle zubbie.
I forni Gill sono uno degli ultimi sistemi di fusione che prese il nome dal suo inventore e si sostituì al calcarone negli ultimi decenni di attività della miniera.
Il forno Gill differiva dal suo predecessore per la copertura dell’ammasso di ganga in muratura anziché con il rosticcio e per la disposizione delle camere di combustione. Esse erano in genere tre o quattro e venivano unite tra loro da canali di comunicazione. L’accensione della prima camera generava la successiva accensione delle altre. Tale sistema permetteva una minore dispersione del minerale e una combustione più veloce e a ciclo continuo.
Questo tipo di fornaci sono ben visibili a Ciavolotta, dove ne esistono delle batterie quasi intatte. Sono in area privata. Gli 3. interventi di conservazione, necessari, necessitano della preventiva acquisizione della loro disponibilità.
Infine, a Ciavolotta la ciminiera costituisce la propaggine più visibile della struttura dell’impianto a vapore che fa parte dell’iconografia ormai storicizzata del luogo. Detto sistema serviva alla raffinazione dei rosticci di zolfo che venivano inseriti in appositi mulini dove avveniva la frantumazione. Le alte temperature fondevano il minerale che veniva poi raccolto ed espunto dalle bocche degli stessi.
La ciminiera, che con quella di Grottacalda, resta l’unico esempio originale di questa tipica struttura architettonica, si trova anch’essa in area privata. Occorre 4. tutelarla e progettarne il suo restauro.
Miniera Cozzo Disi
La miniera è stata sino al 1964 una delle più grandi miniere di zolfo d’Italia e, dopo la chiusura di Perticara e di Cabernardi, la più grande in assoluto.
L’attività estrattiva è definitivamente cessata nel 1988, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 34, che ha sancito la chiusura delle miniere di zolfo siciliane.
Ma, mentre le altre miniere sono state in pratica completamente abbandonate, la Cozzo Disi è stata tenuta in manutenzione sino al 1992, provvedendo anche all’eduzione delle acque.
Il suo sotterraneo, ben conservato sino all’ottavo livello, cioè per circa duecentotrenta metri di profondità, conserva peculiarità mineralogiche e naturalistiche di particolare rarità ed in qualche caso uniche al mondo, come le grandi garbere del terzo livello, che sono maestose cavità carsiche con le pareti ricoperte da immensi cristalli di gesso di eccezionale purezza e trasparenza.
I suoi forni Gill sono stati in piena attività sino al 1954. Erano tanti, non se ne ricorda il numero esatto, ma certamente oltre cinquanta quadriglie. Oggi sono sepolti dai fanghi dell’impianto di flottazione e sono difficilmente riscontrabili se non se ne conosce l’esatta ubicazione, che comunque è a valle dei quattro fumaroli. I fanghi di flottazione sono ormai completamente essiccati e 5. il recupero necessario e non più rinviabile dei forni Gill deve passare attraverso una fase assimilabile agli scavi archeologici, ovviamente costosa. Solo successivamente si potrà valutare quali interventi saranno necessari per la loro conservazione.
Nel frattempo per la loro tutela e per quella dei fumaroli che si trovano a monte di essi, è indispensabile 6. estendere il decreto di vincolo già esistente per il resto dell’area riguardante tutte le altre strutture sopraterra della miniera.
Miniera Floristella
Il permesso di apertura della miniera di Floristella fu concesso l’11 aprile 1825, anche se l’estrazione dello zolfo avveniva anche prima in seguito alla scoperta, nel 1791, del metodo di fabbricazione della soda ottenuta trattando con acido solforico il comune sale.
La miniera conserva il paesaggio tipico: gallerie e pozzi semiverticali sono presenti e visibili; da questi lo zolfo staccato a colpi di piccone era trasportato fino ai calcaroni posti in prossimità delle uscite di pozzi e gallerie.
Una delle strutture più antiche è il pozzo vecchio o di San Giuseppe, che oggi versa nello stato di totale abbandono ed è al momento escluso da ogni ipotesi di recupero e/o intervento conservativo, 7. intervento che è invece prioritario, anche per la sua valenza storica.
Sempre a Floristella è necessario programmare 8. il completamento del restauro di Palazzo Pennisi, già protagonista di un primo intervento di consolidamento e recupero, per farne anche la degna e prestigiosa sede del Parco geominerario delle zolfare.
Edificato tra il 1870 ed il 1885, inizialmente solo fino al piano fuori terra e destinato a residenza estiva della famiglia Pennisi proprietaria della miniera, successivamente fu sopraelevato di altri due piani per soddisfare l’esigenza di alloggi per il direttore e gli impiegati e di locali per uffici. Esso sorge sul fianco della valle del rio Floristella, in cima ad un rilievo che domina l’intera area mineraria, ed è stato pensato quale fortezza inespugnabile dai minatori in caso di scioperi e rivolte; talché, le numerose aperture sono dotate di feritoie e all’interno – oltre agli alloggi, agli uffici, ai vani di servizio, alla cappella a pianta ottagonale, alla carbonaia, ai granai, alle cantine – presenta delle uscite segrete di sicurezza che attraverso le cantine e due piccole gallerie permettevano la fuoriuscita dal Palazzo nel costone sottostante.
Miniera Gessolungo
Le prime notizie storiche della zolfara sono del 1839, con una produzione prospera di 1382,40 tonnellate.
La miniera è segnata da una delle più devastanti disgrazie delle zolfare: il 12 ottobre 1881, durante la discesa dei 250 minatori, avvenne un pauroso scoppio di grisou che investì in pieno la colonna dei zolfatari. Tra picconieri, carusi e tecnici perirono 65 persone e 35 rimasero feriti, diversi dei quali morirono in seguito alle ferite riportate. Le vittime furono seppellite nel cimitero costruito per l’occasione lungo la vie delle zolfare.
E’ di quegli anni la palazzina per il pronto soccorso, oggi di proprietà privata, esempio raro di architettura di fine Ottocento. C’è bisogno del 9. vincolo di tutela per salvaguardarla.
Delle strutture soprasuolo della miniera resta l’importante pozzo Fiocchi, che ha bisogno di un pronto 10. intervento di restauro. Si tratta di un prototipo d’impianto di risalita dei primi del Novecento. E’ uno degli ultimi castelletti in muratura ancora in piedi. I puntoni e i montanti, completamenti eseguiti in blocchi squadrati di pietra di Sabucina, formano due paratie a forma di trapezio rettangolare. In tempi più recenti vi fu costruita sopra la lanterna in cemento armato per alloggiare le mollette.
Miniera Giumentaro
La miniera inizio ad essere coltivata nella prima metà del XVIII secolo. Di quel periodo si conosce il proprietario della miniera, che era la famiglia Crescimanno. L’aspetto generale di una miniera di allora era molto differente da quello più recente, infatti le strutture di superficie erano pressoché inesistenti, ed il lavoro si svolgeva in genere a profondità al quanto ridotta. Si può ritenere che vi fossero delle calcarelle, ovvero le fornaci utilizzate per separare lo zolfo dalla ganga e, forse, qualche fabbricato per i sorveglianti.
Gli affioramenti del minerale si presentavano a poca distanza dal fiume Imera meridionale, continuando a tratti in direzione nord-est sino a quasi alla miniera Giumentarello, situata a monte e aperta nel 1832.
Per la conformità del terreno il sottosuolo della miniera era raggiunto da gallerie orizzontali cui imbocchi si trovavano a quote poco maggiori del livello del fiume. Tra queste c’è da segnalare la galleria San Michele, ancora in discreto stato di conservazione, che, con una modesta somma, si potrebbe 11. recuperare alla fruizione.
Il passo successivo nel potenziamento delle strutture di estrazione era solitamente l’impianto del pozzo di estrazione verticale, ove la conformazione geologica del sottosuolo lo rendesse utile, e sia la miniera Trabonella che la Giumentaro furono dotate di tali strutture sul finire del diciannovesimo secolo. Il castello del pozzo d’estrazione della Giumentaro ha bisogno di 12. un pronto intervento di restauro conservativo.
Miniera Grottacalda
I lavori nella miniera Grottacalda furono iniziati nei primi del secolo XIX al confine di Floristella ed a poca profondità: si estesero poi gradatamente allontanandosi sempre più dagli affioramenti. A seguito dell’estendersi delle lavorazioni la miniera venne fornita di macchinari e furono costruiti i pozzi che funzionarono per alcuni anni con maneggi a cavalli. Con l’approfondimento dei lavori sorse la necessità degli impianti meccanici a vapore per l’eduzione dell’acqua e per l’estrazione del minerale.
A Grottacalda la Montecatini, sin dalle prime acquisizioni societarie ma sopratutto negli anni Trenta del secolo scorso, portò tecnici e impiegati continentali che soggiornavano in loco. Con loro, fu elevata l’efficienza imprenditoriale ed organizzativa, migliorando la vita della miniera. Migliorarono anche le condizioni sociali e di vita nel sito abitativo. Infatti, c’era la scuola elementare, i campi di calcio, tennis e bocce, locali docce per gli operai, lo spaccio per le famiglie che abitavano in miniera, la tabaccheria, la mensa per gli operai, la mensa per i tecnici e gli impiegati, il barbiere che veniva periodicamente da Valguarnera, il cinema aziendale con sala riservata agli operai e tribuna dove prendevano posto gli impiegati e le loro famiglie. C’era il pronto soccorso, una centrale elettrica, una piazza, con al centro una fontana. Sopra una collinetta, a poca distanza dal cantiere, c’era la direzione, l’ufficio postelegrafonico, la caserma dei carabinieri ed una chiesetta dedicata a Santa Barbara nella quale ogni domenica si celebrava la Santa Messa a cura di un sacerdote di Valguarnera a cui l’Amministrazione corrispondeva un’indennità per l’incomodo.
Di questo immenso patrimonio economico e sociale, si segnalano, tra le tante, tre emergenze:
– la ciminiera della centrale elettrica: si tratta di una rara testimonianza di una fase storica della cultura della zolfara quando ancora nelle miniere non arrivavano gli elettrodotti a media tensione e veniva quindi capillarmente impiegata energia autoprodotta con macchine a vapore. Allo stato attuale i locali della centrale elettrica versano in stato di abbandono, mentre la ciminiera è in discreto stato di conservazione, a parte il parziale crollo della sommità causato da un paio di fulmini che l’hanno colpita. Con quella di Ciavolotta resta l’unico esempio di ciminiera ancora in piedi e per la bontà del magistero di messa in opera con mattoni pieni è considerata la più pregevole.
Bisogna progettare 13. l’intervento di consolidamento e restauro;
– la chiesetta di Santa Barbara, che negli anni Novanta ha beneficiato d’interventi manutentivi, versa in condizioni migliori della centrale. Ma allo stato attuale si registrano infiltrazioni d’acqua meteorica, e, ove questa condizione dovesse perdurare, sarà senz’altro di pregiudizio per la staticità del tetto e dell’intera struttura, urge, dunque, 14. un intervento di manutenzione straordinaria.
La chiesetta ospita una pregevole statua di Santa Barbara realizzata nel 1936 dall’artista artigiano di San Cataldo Giuseppe Emma, detto “u zannu”, formatosi alla scuola del Biangardi a Caltanissetta;
– il castelletto in mattoni rossi ha una sua peculiarità nel panorama dei reperti della storia della zolfara. Si trova, come tutto il territorio comprendente la centrale elettrica e la chiesetta, però in area in possesso di privati e, perora, fa parte di un’area recintata e trasformata in ricovero per animali. Molto significativo 15. il suo recupero.
Infine è urgente l’apposizione di 16. un vincolo di tutela per l’intera area di Grottacalda, finora inspiegabilmente non emanato, comprendente tutti i reperti di archeologia industriale presenti.
Miniera Iuncio-Testasecca
La storica zolfara Testasecca faceva parte del vasto gruppo della Iuncio, essendone una delle sezioni principali. Era attiva già nella metà dell’Ottocento e nel 1886 venne acquistata dal imprenditore nisseno Ignazio Testasecca, che la ristrutturò completamente con la costruzione di edifici e impianti adeguati alla tecnologia mineraria di quegli anni.
Fu costruito un singolare castelletto in legno di castagno, unico nel suo genere, ai piedi del pozzo principale, collegato con la sala argano in muratura. Questa struttura in legno resistette fino agli anni Settanta del Novecento, quando, in mancanza di una qualsivoglia tutela architettonica o norma di salvaguardia, fu sciaguratamente abbattuta dai proprietari del terreno.
Di esemplare eleganza è ancora oggi la palazzina, con notevoli spunti liberty, costruita da Testasecca per ospitare gli uffici della miniera.
L’edificio, a pianta rettangolare, è costruito con blocchi squadrati di pietra calacarenitica e presenta una torre di avvistamento nel lato principale che ne costruisce la quarta elevazione. Tutte le aperture a sesto ribassato sono contornate da blocchi squadrati di Sabucina, mentre i cantonali sono contrassegnati con blocchi sagomati e posti in opera con tipica formazione isodoma “attacca e sciogli”. Al piano terra i due portoni principali sono caratterizzati da motivi floreali di chiara ispirazione liberty.
Urge, anche qui, un 17. decreto di tutela e conservazione del bene architettonico.
Miniera La Grasta
L’attività mineraria inizio nella seconda metà dell’Ottocento.
Negli anni Sessanta del Novecento con l’avvento dell’Ente Minerario Siciliano furono completamente rinnovate le tecniche di coltivazione e le tecnologie applicative. Fu costruito il castelletto in struttura reticolare metallica, completo di sala argano, nel pozzo principale. Inoltre, la miniera fu dotata di una centrale elettrica autonoma e di diverse costruzioni adibite ad uffici, spogliatoi, mense e laboratori. Infine, nel sottosuolo, furono rinnovate tutte le gallerie rivestendole in muratura con conci di pietra squadrata.
Nel 1987 fu definitivamente chiusa e lasciata al degrado e all’oblio, depredata e vandalizzata.
Alcuni anni fa il commissario liquidatore dell’EMS, dopo aver pubblicato un bando pubblico, ha venduto a privati l’intera area della miniera, una delle poche completamente di proprietà della Regione. E’ un assurdo paradosso questo che, dopo averla espropriata ai vecchi proprietari e infischiandosene di una legge regionale che aveva trasformato la miniera dismessa in un museo, si sia proceduto alla sua vendita per trasformarla in ricovero e pascolo per animali.
Comunque, le strutture per l’estrazione sono ancora in piedi, così come buona parte dei locali realizzati negli anni di attività.
Visti i lavori fatti dall’EMS di ristrutturazione e consolidamento delle gallerie, si presume che le discenderie siano in discreto stato e facilmente recuperabili. Sono ancora ricche di minerali pregiati, come la celestina. Un 18. intervento per il loro recupero è quanto mai auspicabile per la loro fruizione.
Miniera Tabia-Tallarita
Notizie di una certa attendibilità collocano intorno al 1730 la nascita della Zolfara Grande, in seguito denominata Trabia dal nome del suo proprietario, sita nel territorio di Sommatino. Nel 1823 nacque nel territorio di Riesi la zolfara Fiume Tallarita. Nei primi del Novecento le due miniere divennero le più importanti dell’isola, da sole fornivano il 12% della produzione di zolfo della Sicilia.
I forni Gill di Trabia e di Tallarita necessitano di 19. interventi urgenti perché, a quanto si sa, si tratta degli ultimi esemplari esistenti di sestiglie tipo Gatto, cioè dell’evoluzione più avanzata del forno Gill a quadriglia che è il più diffuso in tutte le zolfare sia siciliane che del territorio nazionale. Purtroppo, negli ultimi anni sono stati pesantemente vandalizzati, con l’asportazione dei conci di pietra squadrata che formano gli archi d’ingresso. Alcuni di loro, a causa di ciò, sono crollati all’interno.
La cosiddetta nave è il silos nel quale si “stoccava” il minerale all’uscita dal pozzo per avviarlo successivamente all’impianto di flottazione mediante una teleferica della quale ormai resta ben poco. La struttura, diventata per le sue dimensioni il simbolo di quello che rimane degli impianti della miniera, è stata pesantemente depredata. Non c’è più traccia della batteria di vagoncini presenti fino a tre/quattro anni fa. Trattandosi di una struttura metallica, se si vuole darle un aspetto di reperto e non di rottame di cui disfarsi, bisogna intervenire con 20. trattamenti protettivi sulle strutture metalliche e di consolidamento su quelle portanti. Dietro di essa è collocato il pozzo Vitello, dov’è installato il più alto, ma anche il più recente, castelletto del bacino. Ancora più avanti si trovano le strutture del vecchio pozzo principale, con il castelletto in telaio di ferro dei primi del Novecento con accanto la sala argano.
In quello che era un vero e proprio borgo attrezzato, con tanto di casermetta dei carabinieri e ufficio postale, c’è da segnalare per un necessario intervento di recupero 21. la cappella dedicata a Santa Barbara, ad unica aula, e 22. la palazzina adibita ad alloggi per gli impiegati scapoli, una struttura divisa in due corpi di fabbrica, a due piani.
Tutti i reperti sopra riportati ricadono in area in possesso di privati.
Miniera Trabonella
Non si conosce l’anno della concessione di “aperiatur”, la tradizione orale pone l’inizio dei lavori nel 1825. La prima notizia si evince dalla statistica generale delle zolfare in Siiclia del 1839, quando il proprietario era il Barone Trabonella.
E’ una della miniere ad avere le strutture di escavazione e di lavorazione dello zolfo meglio conservate, ma che hanno, comunque, bisogno di urgenti interventi di recupero e restauro. A cominciare dal 23. pozzo nuovo, che mostra qualche segno di instabilità che non deve essere ignorato se si vuole inserire la Trabonella in un percorso di fruizione storica della epopea della zolfara. La struttura è acciaio reticolare, esempio dell’ultima fase della tecnologia mineraria. L’eventuale suo collasso annienterebbe qualsiasi programma di riconversione museale del sito. Si deve preventivamente procedere ad un monitoraggio strumentale della stabilità degli ancoraggi del castelletto e successivamente passare al consolidamento dell’area di sedime e al restauro conservativo della struttura.
Tra le testimonianze architettoniche più significative si segnalano:
– il riflusso Nuvolari (ovviamente riferendoci alla sola struttura di superficie), che ha bisogno di 24. un intervento conservativo che, viste le sue buone condizioni, non dovrebbe essere gravoso. Il riflusso Nuvolari fu realizzato nel 1898 a seguito della rivoluzione tecnica apportata dall’imprenditore lombardo Gedeone Nuvolari, affittuario in quegli anni della miniera. C’è, però, da ripristinare tutta la viabilità per accedervi che in atto è praticamente inesistente;
– il grande edificio degli uffici, che ha bisogno di 25. un completo intervento di recupero e restauro, è a pianta ad “U” a tre piani e copertura a doppia falda. Nei muri perimetrali in pietra squadrata di Sabucina si trovano numerose finestre, balconi e portoni con archi a tutto sesto.
Bisogna evidenziare, infine, che alla Trabonella non si può avviare nessun intervento se non si procede allo smaltimento dei manufatti in eternit.
L’area della miniera Trabonella è dal 1998 di proprietà del Comune di Caltanissetta.
Le 25 cose da fare subito per l’archeologia industriale delle zolfare siciliane
1. recupero dell’imbocco del piano inclinato “Libia” della miniera Ciavolotta
2. ripristino dell’accesso sotterraneo alle zubbie della miniera Ciavolotta
3. intervento conservativo dei forni Gill della miniera Ciavolotta
4. progetto di tutela e restauro della ciminiera della miniera Ciavolotta
5. recupero e restauro dei forni Gill della miniera Cozzo Disi
6. estensione del vincolo di tutela per l’area dei forni Gill e dei fumaroli della miniera Cozzo Disi
7. recupero del pozzo vecchio o San Giuseppe della miniera Floristella
8. completamento del restauro di Palazzo Pennisi a Floristella
9. vincolo di tutela per la palazzina di pronto soccorso della miniera Gessolungo
10. restauro del pozzo Fiocchi della miniera Gessolungo
11. recupero alla fruizione della galleria San Michele della miniera Giumentaro
12. restauro conservativo del pozzo d’estrazione della miniera Giumentaro
13. intervento di consolidamento e restauro della ciminiera della miniera di Grottacalda
14. intervento urgente di manutenzione nella chiesetta di Santa Barbara a Grottacalda
15. restauro dell’antico castelletto della miniera di Grottacalda
16. imposizione del vincolo di tutela all’intera area di Grottacalda
17. imposizione del vincolo di tutela per la palazzina uffici della miniera Iunco-Testasecca
18. intervento di recupero delle discenderie della miniera La Grasta
19. recupero dei forni Gill della miniera Trabia-Tallarita
20. recupero dell’impianto nave della miniera Trabia-Tallarita
21. restauro della chiesetta dedicata a Santa Barbara della miniera Trabia-Tallarita
22. restauro della palazzina adibita ad alloggi per gli operai scapoli della miniera Trabia-Tallarita
23. restauro conservativo del pozzo nuovo della miniera Trabonella
24. intervento conservativo del riflusso Nuvolari della miniera Trabonella
25. recupero e restauro del grande edificio uffici della miniera Trabonella
—
Riceviamo la seguente puntualizzazione da Salvatore Di Vita, funzionario direttivo presso il Parco Minerario Floristella Grottacalda:
“Con riguardo al dossier di Legambiente Sicilia sulle zolfare siciliane, pubblicato nella home di Vivienna.it, io sottoscritto, indicato tra coloro che hanno contribuito alla redazione del medesimo documento, preciso di non aver mai autorizzato la citazione del mio nome e di non gradire l’accostamento dello stesso all’iniziativa “25 cose da fare subito per l’archeologia industriale delle zolfare siciliane”. Naturalmente, la presa di distanza non riguarda la sostanza dall’iniziativa in sé, a cui ho profuso condivisione ed energie e sicuramente ne profonderò in futuro, riguarda invece il disegno di legge che subdolamente accompagna il dossier di Legambiente Sicilia, che, ove non stroncato sul nascere, produrrebbe incertezze ed in ultimo gravi danni alla stessa “cosa” che si vuole proteggere. Ciò perché l’impianto dell’articolato normativo, così come redatto dai pochi intimi in assenza d’interlocuzione, esemplifica malamente due momenti distinti dell’azione che si vorrebbe condurre: in primis, l’istituzione del nuovo Parco geominerario delle zolfare siciliane (Art. 1, comma 1); in secundis la soppressione dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda (Art. 1, comma 3, e Art. 12, comma 1). Il pericolo sta nel fatto che, mentre la soppressione dell’Ente Parco di Floristella avrebbe effetti immediatamente conseguenti all’approvazione della legge, l’effettiva funzionalità del nuovo Ente sarebbe legata ad una serie di provvedimenti da adottarsi successivamente con decreti dell’assessore regionale ai beni culturali (perimetrazione definitiva del parco, nomina del presidente, del direttore, degli esperti, regolamento di organizzazione e gestione, trapasso del personale, ecc.). Ora, poiché la storia dell’ordinamento regionale siciliano è piena di cose monche e/o parzialmente realizzate, ed in considerazione del difficile momento istituzionale caratterizzato da instabilità politica, appare quantomeno imprudente promuovere un’azione legislativa nei termini in cui è stata proposta con il disegno di legge di Legambiente. Un salto nel buio di dubbio sapore, con la spoliazione di un qualcosa -l’Ente Parco Floristella, appunto- che comincia a funzionare e che potrebbe avere interessanti sviluppi per il comprensorio territoriale ennese. Vigilino la deputazione locale, i sindaci, le amministrazioni e la politica e le popolazioni in genere”.
Salvatore Di Vita